Il miracolo di quegli ottocento della Cattolica
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:

Il Cristianesimo come avvenimento, nei licei e nelle università
Giorno verrà in cui di questa incredibile storia si dovrà fare un gran bel film: per ora non è possibile, visti i presupposti dell’industria culturale imperante, ma il giorno sicuramente verrà, perché, come diceva Eliot, “l’uomo che è adombrerà l’uomo che pretende di essere”. Per ora, comunque, mi sento in dovere di dare la mia personale testimonianza su un fatto che, mi auguro, possa essere conosciuto da tutto il mondo cattolico, affinché possa averne luce per il suo faticoso cammino nel mondo. Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei: di te si dicono cose stupende, città di Dio (Salmo 86/87). Ecco, vogliamo considerare un fatto in cui si è mostrata attraverso centinaia di giovani la gloria della città di Dio, che è la Chiesa.
Il fatto di cui vogliamo parlare è quello di una comunità cristiana di studenti universitari presente pubblicamente dentro il loro ateneo, come esempio concreto e vivente di cosa intendesse don Giussani quando invitava tutti i cristiani a vivere la loro missione nel mondo rendendo presente il Cristianesimo come un avvenimento e non come un moralismo individuale. Nessuno si convertirà mai ad un Cristianesimo ridotto ad una filosofia di vita interiore (quasi sempre funzionale alla cultura dominante), ma solo ad un incontro vivo con un avvenimento vivo. Il volto e la natura di questo avvenimento è la compagnia o unità di uomini e donne reali che credono in Cristo e vivono una comunione reale di vita con Lui e in Lui. È Cristo stesso che lo ha stabilito: basta leggere il discorso dell’Ultima Cena nel Vangelo di Giovanni (capitoli da 13 a 17) per comprendere come Gesù voglia che i suoi discepoli siano, visibilmente e pubblicamente, una sola cosa con Lui e il Padre, perché il mondo creda in Lui; per questo parla di amicizia e di amore reciproco, non come atteggiamenti generici e vuoti, ma come esperienza di una fraternità-compagnia-unità reale nel suo nome.
Se questa compagnia non si rende presente, visibile, udibile e incontrabile dentro gli ambienti di vita dell’umanità del nostro tempo, non c’è nessuna possibilità che Cristo sia conosciuto e seguito. Questa è stata l’intuizione di don Giussani. Per questo ha dedicato la vita ad annunciare la vera fede e a renderla esperienza di una compagnia vivente presente dentro i licei e le università italiane, perché erano questi i luoghi in cui vivevano tutti i giovani italiani, soprattutto a partire dalla metà del Novecento. Questi due ambienti, infatti, non sono solo i luoghi dove i giovani passano la quasi totalità del loro tempo, ma ancor più dove ricevono la formazione della loro intelligenza, della loro coscienza, del loro io e della società che costruiscono tra di loro e che costruiranno poi nel resto della loro vita. Ignorare questa evidenza esistenziale mondiale significa essere fuori dalla realtà.
Questa considerazione riguarda la missione di tutta la Chiesa verso i giovani. Una ‘pastorale giovanile’ che non porti la sua presenza e la sua opera soprattutto dentro i licei e le università e che vada a cercare i giovani sulle spiagge o nei bar o sui muretti, è fuori dal mondo per due ragioni: primo, perché non va là dove i giovani vivono, crescono, si formano, perdono la fede e hanno bisogno di incontrare Cristo; secondo, perché anche se raduna dei giovani e li porta alla fede, se poi essi non vengono mandati in missione nel loro ambiente fondamentale e non rendono presente in esso il Cristianesimo come avvenimento, cioè la compagnia dei credenti o Chiesa, quei giovani non sono veramente cristiani, ma tuttalpiù simpatizzanti.
Giussani giustamente si chiedeva: se un giapponese venisse in un liceo o in una università italiana e volesse confrontare la sua religione con quella dei cristiani, riuscirebbe a trovarli? C’è qualche segno oggi della presenza cristiana nei licei e nelle università? La realtà è che non ne troverebbe alcuna traccia. Se però volesse confrontarsi con gli appassionati di un certo sport o di una certa musica o di una certa corrente politica, ne troverebbe a non finire. Come possiamo noi cristiani restare indifferenti di fronte a questa nostra assenza totale?
Per rimediare a questa situazione avvilente, occorre non l’ennesimo progetto umano o ‘piano pastorale’, ma l’attenzione a quello che lo Spirito Santo ha suscitato per aiutare la sua Chiesa. Come alla metà dell’Ottocento Egli ha suscitato il carisma di San Giovanni Bosco per coinvolgere i giovani, dispersi nella rivoluzione industriale, in una nuova esperienza di Chiesa, così alla metà del Novecento ha suscitato il carisma di don Giussani per rendere presente la Chiesa tra i giovani dei licei e delle università. Questo è ciò che hanno detto unanimemente gli ultimi tre Sommi Pontefici. Si tratta allora di guardare a ciò che questo prete lombardo ha realizzato, per imparare e mettersi all’opera.
Don Giussani, constatando l’assurda assenza del Cristianesimo dalle scuole superiori degli anni Cinquanta, ha chiesto al Vescovo di lasciare l’insegnamento universitario per fare il professore di religione nei licei milanesi (basterebbe questo auto-declassamento, che non viene mai optato da nessuno, per far sospettare la presenza della santità in un uomo). Entrato così nel Liceo Berchet di Milano, ha chiesto a sorpresa ad alcuni giovani studenti se erano cristiani: siccome lo erano, benché non volessero dirlo a nessuno, ha detto a loro di vivere con lui la comunione in Cristo e di rendersi presenti pubblicamente in quel liceo. Da quel gruppetto di tre studenti è cominciato tutto. Nel corso di dodici anni sono diventati duemila, in vari licei di Milano. Poi sono arrivati all’università e col tempo sono diventati molte migliaia. E qui comincia la nostra storia.
Una realtà superiore ad ogni immaginazione
Questa incredibile storia si è svolta dal 1986 al 1990, o, meglio, quelli sono gli anni in cui io ne sono stato testimone, mentre essa in realtà si è svolta già a partire dagli anni Settanta ed è tuttora in corso. Non è quindi solo un fatto del passato, ma anche del presente. Tuttavia narreremo qui l’esperienza di quegli anni passati, perché è esemplificativa di un fenomeno molto più ampio nel tempo e nello spazio, essendo le comunità del CLU (Comunione e Liberazione Universitari) presenti in tutti gli atenei d’Italia. Poi, si sa, ogni momento del tempo o dello spazio ha avuto la sua peculiarità ed è bene che non vada perduta.
In quegli anni ero un giovane prete trentino, mandato a studiare filosofia e comunicazioni sociali all’Università Cattolica di Milano. Essendo di CL conoscevo bene alcuni giovani ciellini trentini (Walter, Filippo, Paolo - ora don Paolo -, Maurizio, Isabella e altri) che studiavano in quell’ateneo e da loro mi sono fatto aiutare per inserirmi nell’ambiente. Quello che ho visto e incontrato, a cominciare dall’entusiasmo dei suddetti trentini, è stato una comunità di CL di ottocento universitari di varie facoltà della Cattolica (filosofia, storia, lettere, giurisprudenza, scienze politiche ed economia), la cui realtà mi è apparsa sempre di più come di gran lunga superiore ad ogni immaginazione. Quello che vorrei fare, sapendo che purtroppo è quasi impossibile, è dare un’idea di questa realtà che, non ho dubbi, va classificata come un miracolo. Anzi, un miracolo imponente, che da solo potrebbe bastare per la beatificazione di chi, in nome di Cristo, ne è stato per così dire l’esecutore, vale a dire don Luigi Giussani.
Il treno intercity “Leonardo Da Vinci” che collegava Rovereto con Milano ogni domenica sera proveniva da Monaco di Baviera ed era fatto di vagoni a scompartimento unico, arredati a modo di salotto, con ampio uso di moquette. Quella sera salendo sul treno ho trovato come sempre Paolo e gli altri già sistemati nel salottino centrale del vagone. Dopo un po’ il futuro padre generale della Fraternità San Carlo, cioè Paolo, ha avuto la bella idea di offrire un po’ di grappa locale a tutto il nostro gruppo. Rimettendo poi al suo posto la bottiglia nella valigia collocata sul ripiano in alto, una manovra incauta ha fatto cadere per terra il bagaglio, causando la rottura della bottiglia, per cui in pochi secondi la moquette si è riempita di profumata grappa trentina. Gli altri viaggiatori, infastiditi dagli aromi del superalcolico, hanno deciso di cambiare vagone e così ci siamo trovati con ampio spazio a nostra disposizione, mentre il buon Paolo si dava da fare col nostro aiuto per asciugare il pavimento e l’arredamento del vagone …
Sì, ogni domenica sera si scendeva a Milano insieme, quantunque spesso accadesse di rimanerci per più settimane, in base agli impegni della comunità del CLU. Era questa comunità, infatti, il cuore della nostra vita e della nostra amicizia. 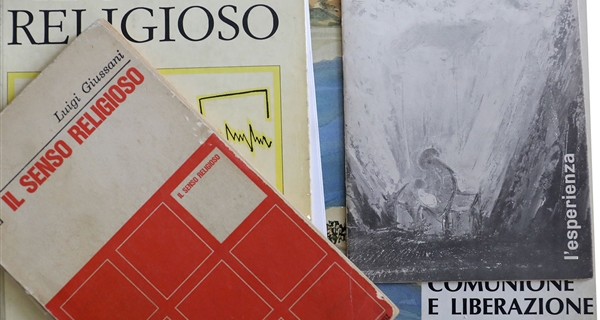
L’impatto quotidiano con una presenza
La si trovava subito arrivando in ateneo: anzitutto perché il grande portone di ingresso era circondato a destra e a sinistra da grandi ‘tazebao’, scritti rigorosamente a mano, su cui i nostri amici addetti a questo servizio esponevano il nostro giudizio sui fatti di attualità del mondo, della Chiesa e dell’università, commentando spesso articoli dei grandi giornali o frasi di grandi autori della letteratura o affermazioni del Papa o di varie autorità. Era un fenomeno che non mancava mai, ogni giorno dell’anno, perché don Giussani teneva moltissimo alla comunicazione pubblica di ciò che apriva la mente e il cuore e alla coscienza che dovevamo averne. Mi ha sempre stupito molto questa capacità di giudizio e questa costanza quotidiana nel rendere visibile pubblicamente il richiamo alla verità delle cose. L’uomo, infatti, ha bisogno di un richiamo continuo alla verità, altrimenti scivola costantemente in basso, verso la sua istintività che chiude ogni orizzonte. San Paolo diceva giustamente che la battaglia quotidiana è tra lo Spirito, che ci innalza verso il vero, e questa istintività, che ci spinge a vivere nei nostri circoli viziosi. Deporre le armi in questa battaglia significa arrendersi alla cultura dominante, che è appunto la massima espressione del gabbione sempre uguale in cui gli uomini si rinchiudono.
Ma non erano solo i tazebao a rendere subito visibile la presenza di CL nell’università: c’erano anche i ‘banchetti per le matricole’, ovvero una serie di tavoli lungo il marciapiede della strada pubblica che passava davanti all’ingresso della Cattolica. Dietro a questi tavoli c’erano, a turno, studenti del CLU delle vare facoltà (ogni tavolo portava la scritta della facoltà che rappresentava) per aiutare le matricole a orientarsi nel complicato mondo delle pratiche burocratiche amministrative, del complesso quadro dei corsi (obbligatori, opzionali, seminariali, etc), dei luoghi di ristoro o di studio personale. Non solo, ma si offriva la possibilità di far parte di gruppi di studio guidati per superare l’esame più difficile del primo anno (come il mitico esame di matematica per Economia o di diritto privato per Giurisprudenza). A dare le indicazioni erano sempre studenti e non adulti, in modo da far sentire le matricole a loro agio e vivere la presenza in mezzo alla propria generazione.
Entrati poi nell’ateneo, a destra del camminamento di ingresso c’era la Cappella Universitaria, dove ogni giorno venivano celebrate tre Sante Messe. La più frequentata era quella settimanale con Padre Manuel, dove i ciellini cercavano di entrare finché c’era spazio (più o meno un massimo di trecento persone in piedi). Poi, lungo la settimana, si trovavano molti studenti di CL a tutte le Messe. Anch’io concelebravo o celebravo ogni giorno, e trovavo sempre molti studenti della comunità. Don Giussani aveva fatto della Messa quotidiana il cuore della vita del movimento, perché ciò che vi accade è Cristo stesso e la comunione con Lui. Era Cristo, infatti, il centro di tutto: questo era l’ideale che dava forza e vita al Movimento. Perciò, senza che ci fosse alcuna pressione in questo senso, era naturale che i giovani ciellini cercassero di andare alla Messa quotidiana, vissuta con essenzialità, ordine e bellezza, soprattutto attraverso il canto. Per questa ragione il Gius non voleva che il sacerdote facesse da protagonista, ma da umile servitore della presenza di Cristo, evitando i tempi lunghi e le parole inutili.
La mattina, poi, si trovavano a varie riprese gruppetti di ciellini in chiesa per la recita delle lodi o dell’Angelus, prima delle lezioni. Non si capirebbe nulla del miracolo di cui stiamo parlando se non si riconoscesse la Causa sovrumana che lo generava quotidianamente. D’altro canto non si capirebbe nulla della liturgia se non fosse il cuore di una vita intera vissuta con Cristo, includendo lezioni, pranzi, cene, viaggi nella metro, studio, amicizie, vacanze, letture, canti … Tutta la vita, infatti, se vissuta con Cristo documenta che Cristo è vero. Questa scoperta è decisiva per la nascita di una coscienza cristiana e non può accadere se non nell’esperienza di una esistenza comunitaria realmente determinata dalla fede (cioè dalla applicazione della fede a tutto).
Nei chiostri della Cattolica si svolgeva la vita accademica, con i vari corsi. In mezzo alle aule adibite alle lezioni, ce ne erano due dedicate stabilmente alla grande compagnia dei ciellini: una come sede-segreteria e luogo delle riunioni dei responsabili (Alessandro Giavarini era il capo, insieme con vari amici, tra i quali ricordo Michele Faldi, Chiello, Camillo Fornasieri, Davide Perillo, Marco Zibardi …) o di vari gruppi di lavoro, l’altra come luogo di studio individuale o a gruppetti.
Quest’ultima, detta ‘Aula San Giovanni’, era piuttosto grande, a gradinate, con molte file di banchi: c’erano sempre molti studenti al lavoro, a tutte le ore. Studiare insieme aiuta a capire e a ripassare-memorizzare: è un’altra occasione per vivere la grande amicizia, quella che ci unisce al Destino e trasforma ogni istante della quotidianità. C’erano poi i gruppi di aiuto alle matricole, dove quelli che avevano già superato bene l’esame più ostico aiutavano i più giovani a prepararsi al meglio; così che poi quelli che sono stati aiutati potranno più avanti essere coloro che aiuteranno.
La segreteria, invece, era anche il deposito dei tavoli e dei materiali dei banchetti delle matricole, del necessario per scrivere i tazebao, del materiale vario per i gruppi di Scuola di Comunità o per le vacanze o per i volantinaggi o per la diffusione di libri e opuscoli. Regnava sovrano il fumo delle sigarette, ma all’epoca era considerato parte della condizione umana.
La Scuola di Comunità, ovvero la coscienza della verità
Ogni settimana o ogni quindici giorni si faceva il raduno di Scuola di Comunità (SdC), divisi per le sei facoltà. Noi di filosofia eravamo una settantina. Di volta in volta venivano assegnate dall’ateneo le aule per queste convocazioni, che erano sempre aperte al pubblico. A guidare l’incontro era lo studente che era stato designato dal Movimento come responsabile della comunità di quella facoltà. Ci si confrontava sul testo di don Giussani, con testimonianze o domande.
Giustamente l’appartenenza al Movimento è stata fatta coincidere soprattutto con la partecipazione alla SdC, perché tale appartenenza è una decisione della coscienza e la coscienza ha bisogno di avere chiare le ragioni per cui appartenere. Questo vale per il Cristianesimo in generale ed è quello che Gesù stesso ha definito con parole insuperabili: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8); «Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» (Gv 18); «Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità» (Gv 17).
La missione della Chiesa è quella di annunciare Cristo, che è la verità. È la grande questione della fede, che è il riconoscimento di Cristo e della sua presenza. È dunque questo il compito della SdC: conoscere la verità e consacrare la vita alla verità. Ciò significa paragonare ogni aspetto della vita con la verità: per questo il lavoro dei gruppi di SdC non deve mai limitarsi ad una conoscenza ‘teorica’ della verità, ma alla testimonianza di come la verità ha inciso su un aspetto o un altro dell’esistenza.
Vedere centinaia di studenti universitari impegnati in questo lavoro è impressionante, perché essi di solito sono l’emblema dell’abbandono della fede. Vederli poi fare questo dentro le loro università, sfidando apertamente la mentalità dominante, è una cosa dell’altro mondo … in questo mondo.
Di tanto in tanto il raduno di SdC veniva fatto tutti insieme, convocando tutti i gruppi di facoltà in un’unica assemblea, talvolta con don Giussani stesso, o addirittura in un raduno cittadino, con gli studenti di tutte le università di Milano, per la giornata di inizio anno a settembre. Questa giornata consisteva in un gesto essenziale: il convenire nel palazzetto di tutti i gruppi, i canti introduttivi, la lezione di don Giussani, la Santa Messa, gli avvisi conclusivi. Era il gesto in se stesso che costituiva un richiamo potente alla nostra appartenenza a Cristo: Egli faceva sentire la sua presenza già solo nel fatto che ci portava tutti a Sé per radunarci, parlarci e mandarci in missione. Come si vedrà più avanti, era la serietà del gesto che ci stupiva, senza che per questo venisse meno il sorriso e la letizia nei cuori. C’è da chiedersi come una simile libera e numerosissima aggregazione di universitari per seguire l’ideale cristiano non facesse sobbalzare di gioia il mondo cattolico …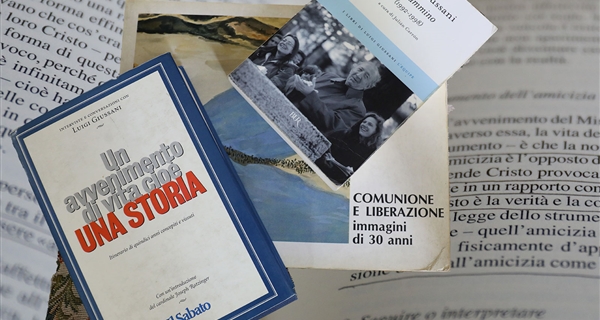
Ottomila studenti universitari italiani agli Esercizi spirituali annuali
Oltre alla giornata di inizio, durante l’anno la vita della comunità era scandita da alcuni momenti forti. Il più importante era quello degli “Esercizi del CLU”, ovvero gli esercizi spirituali per tutto il CLU italiano nel mese di dicembre all’Immacolata. All’epoca eravamo circa tremilacinquecento (nel 1977, quando ero in Seminario, a Riva del Garda eravamo 1800, con don Giussani, quando ci spiegò la sonata di Chopin), ma negli anni successivi la cifra andò via via aumentando arrivando ad un massimo di ottomila nei primi anni del terzo millennio. Lo ripeto, stiamo parlando di studenti universitari, cioè della categoria di persone considerate le più lontane dalla Chiesa Cattolica e le più coinvolte nell’ateismo militante e nella cancel culture … È inconcepibile che accada una cosa simile: migliaia di giovani laureandi, seduti in silenzio ad ascoltare l’annuncio della fede, ad ascoltare la Santa Messa ogni giorno tutti insieme, a confessarsi, ad assistere alla testimonianza della sera, a cantare ad una sola voce, a pregare i salmi, a sentire Chopin o Beethoven e la loro interpretazione, a spostarsi in pullman in silenzio, decidere in cuore di dare la vita per Cristo e la sua compagnia … Non si dovrebbe gridare al miracolo? Gesù aveva detto: «In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre» (Gv 14). Se è un miracolo vedere un paralitico che si alza in piedi, perché si capisce che solo Dio può farlo, non è forse ancora più grande vedere una o migliaia di giovani coscienze atee che abbracciano Cristo e lo seguono per tutta la vita?
Se gli Esercizi del CLU sono il momento forte più grande dell’anno, qualcosa di simile si verificava anche a Pasqua, con la Via Crucis vissuta tutti insieme a Caravaggio con don Giussani. Era il gesto educativo alla sequela di Cristo: seguire Lui che porta la croce del mondo per salvare il mondo. Anche in questo caso la preoccupazione di don Giussani era quella di favorire in ciascuno la coscienza di ciò che stava accadendo, attraverso una serie di letture e di canti accuratamente selezionati: assistere ad un bel gesto di cui non si comprende il significato non serve a nulla, è come un ultrasuono che nessuno percepisce; perciò occorre l’umiltà di far sentire qualche grande testo, come quelli di Péguy, che dia un aiuto straordinario all’uomo di oggi a comprendere chi è e che cosa ha fatto Cristo.
Uno stile provvidenziale
C’è un’osservazione importante sullo ‘stile’ con cui erano strutturati questi gesti del Movimento e anche i raduni, le assemblee, le Equipe, e via dicendo. Tutto, infatti, avveniva in un clima di impressionante cura e serietà: il numero delle sedie coincideva con il numero dei partecipanti, tutto era disposto con la massima razionalità e funzionalità, il servizio d’ordine assicurava il riempimento di tutti i posti progressivamente, i canti erano ben preparati ed seguiti sollecitamente evitando ogni intervallo vuoto, il silenzio era sovrano … Era un clima di serietà inusuale per i raduni cattolici: sembrava di essere ad un evento scientifico o militare della massima importanza, in cui era richiesta la maggior attenzione possibile, ed invece era un evento spirituale, vissuto con la consapevolezza di essere stati convocati da Cristo stesso, presente in persona, in un momento di grande drammaticità per il mondo. Perché in effetti le cose stavano esattamente così. Non c’era nulla di imposto, nulla di violento, nessuna volontà di potenza o di potere: la mitezza e la serenità erano sovrane, pur nella consapevolezza della drammaticità della storia.
Questo stile permetteva di prendere veramente sul serio il Cristianesimo, anzi, di considerarlo la cosa più seria in assoluto, come appunto dovrebbe essere sempre. La serietà dei gesti faceva sentire di essere di fronte alla questione più alta e drammatica per l’umanità, cioè Cristo stesso: Egli era ed è la questione decisiva, non per gli addetti ai lavori dello spirito, ma per l’umanità in quanto tale, con la sua esigenza costitutiva di infinito. L’umanità era spinta dalla cultura dominante a dimenticare Cristo, a cancellarlo, a costruire un mondo senza di Lui. Il raduno della comunità era invece il movimento dell’umanità che riconosce che Cristo è tutto, è ciò che di più caro abbiamo al mondo, è il destino vero del mondo.
Perciò il raduno della comunità era il punto di svolta del mondo, il ritorno alla vita, alla speranza, al destino, alla verità, alla luce. Per questo era la questione più seria in assoluto.
A questo proposito occorre fare chiarezza su un equivoco abbastanza diffuso: i ciellini, nella stragrande maggioranza dei casi, non erano cattolici da sempre o addirittura ‘cattolici muscolari’ in attesa di essere messi insieme da qualche leader carismatico; no, essi erano giovani laici, magari di famiglia cattolica, ma lanciati come tutti i loro coetanei verso il mito della scienza e del progresso, senza più nessun legame con la parrocchia o addirittura con la Chiesa Cattolica stessa. Sono diventati cristiani o sono tornati ad esserlo solo dopo aver incontrato nella scuola o nell’università la realtà del Movimento, cioè l’avvenimento cristiano come realtà vivente e carica di ragioni.
Quando dunque nel mondo cattolico si parla di ‘lontani’ o di ‘mondo’ si dovrebbe stare attenti a non identificarli con certe formazioni politiche o certe categorie sociali di emarginazione: i ‘lontani’ sono anzitutto gli studenti delle scuole e delle università, i quali attendono che il Cristianesimo si renda presente lì dove vivono per poterlo conoscere. Perciò invece di parlare e discutere sui ‘lontani’ o sul ‘mondo’, bisognerebbe semplicemente lavorare per la presenza della compagnia cristiana viva e autentica dentro i licei e gli atenei.
Le vacanze e il Meeting
C’erano poi due momenti forti durante l’estate: la vacanza in montagna con la comunità del proprio ateneo in luglio e il Meeting di Rimini a fine agosto.
La vacanza in montagna era un momento di grande bellezza, dopo la fatica degli esami di giugno/luglio. Noi della Cattolica eravamo in 650, a Mazzin di Fassa, per sette giorni. Un paio di grandi gite a piedi tra le cime dolomitiche, un paio di giorni di gioconi molto combattuti, una testimonianza importante di qualcuno inviato dal Movimento, la Santa Messa tutti i giorni (durante la gita si celebrava in mezzo alle cime), serate di canti … La bellezza di tutto questo stava soprattutto nel fatto che si voleva appartenere a tutto questo, cioè nel fatto che le persone erano consapevoli di ciò che significava e lo desideravano. Era la SdC che creava questa coscienza e rendeva possibile un gesto che non fosse esterno a ciascuno di noi, ma parte di noi. Come diceva Gaber in una sua canzone: “L’appartenenza è avere gli altri dentro di sé”.
La vacanza estiva merita qualche aneddoto. Il 17 luglio 1988 San Giovanni Paolo II era stato invitato a celebrare la Santa Messa al santuario mariano di Pietralba, in Alto Adige, in mezzo alle Dolomiti, ad una altezza di 1500 metri. Noi eravamo a Mazzin, ad una distanza di circa un’ora e mezza di automobile. Perciò i responsabili decisero che avremmo partecipato a questo gesto.
Siamo dunque partiti da Mazzin alle cinque del mattino: eravamo in 650, suddivisi in 90 macchine e due pullman; ci siamo incolonnati tutti sulla strada seguendo le indicazioni del nostro servizio di segreteria e quando siamo stati pronti siamo partiti tutti insieme, viaggiando in colonna fino a Pietralba. Era un giorno di sole magnifico, sul grande prato in discesa di fronte al santuario, con la presenza di 55 mila fedeli. La Chiesa in questi gesti appare veramente nella sua maestosa bellezza di popolo unito, ordinato, concentrico rispetto a Cristo e al Successore di Pietro, tra i canti e le parole solenni della liturgia, sotto il cielo infinito che ci avvolge.
Terminata la Santa Messa, il popolo lentamente si è incamminato verso i parcheggi. Noi della Cattolica siamo rimasti da soli e ci siamo avvicinati al Santuario, dentro il quale, nel convento dei frati, il Papa e i vescovi pranzavano insieme. Ci siamo seduti sull’erba e abbiamo mangiato il pranzo al sacco; poi abbiamo cantato per due ore, svolgendo un repertorio notevole di canti della montagna e di canzoni del Movimento, sotto la direzione di Guido Castelli. Ad ascoltarci c’erano solo quattro o cinque guardie del Vaticano, che vigilavano sull’esterno del Santuario. Verso le 15 il nostro Marco Zibardi è riuscito a parlare con gli accompagnatori del Papa e ad ottenere l’impossibile: la finestra del secondo piano si è aperta e il Papa è uscito per noi, con un microfono che gli ha permesso di dirci alcune parole, tra le quali ricordo queste: “Tutti dopo pranzo dormono, ma voi cantate!”. Scherzò amichevolmente con noi, ci incoraggiò a continuare e ci diede la sua benedizione e anche il suo Rosario! E tornammo a Mazzin tra la terra e il cielo …
Non so se in quell’anno o in quello successivo, ci recammo in gita al Rifugio Contrin, sopra Alba di Canazei. A lato del rifugio, nella splendida conca ai piedi della parete più vertiginosa della Marmolada, ci sono alcuni sali-scendi erbosi, sui quali ci siamo seduti dopo il pranzo per cantare, sempre condotti da Guido Castelli. Abbiamo cantato a lungo. C’erano molti escursionisti di passaggio, i quali, sentendo i nostri canti della montagna e vedendo questa ‘compagnia impossibile’ di centinaia di giovani universitari e universitarie, si fermavano stupiti. Era davvero uno spettacolo inspiegabile, nel contesto non solo dei luoghi turistici, ma del mondo moderno nella sua interezza, dove ciascuno va per conto proprio, alla ricerca di relazioni assai difficili da costruire e da mantenere. Vedere quindi un’unità evidente di centinaia di amici, pieni di entusiasmo e di vita, era qualcosa che superava la bellezza pure incantevole delle grandi cime circostanti. Eravamo noi lo specchio del cielo.
Mi rendevo sempre più conto che se una compagnia così fosse visibile il sabato sera nelle nostre città, sarebbe impossibile resistere al suo fascino. Ma anche per questo, giorno verrà.
In una delle nostre vacanze a Mazzin combinammo un incontro con i 250 amici della Bocconi, che erano in vacanza sotto il passo Pordoi ad Arabba. Il punto di ritrovo fissato fu il passo, nel prato sotto il monumento della prima guerra mondiale. I nostri responsabili ebbero l’idea di organizzare a sorpresa un assalto militare agli amici bocconiani e ci preparammo accuratamente la sera precedente in albergo: cento erano armati di fucili ad acqua, cento di gavettoni e cento ragazze di pugni di farina. Arrivati al passo in anticipo ci sistemammo nel prato, in attesa degli ignari supereconomisti. Quando arrivarono a piedi tutti insieme, cantarono canti di festosa amicizia, non sapendo cosa li attendeva. Li fecero sedere in modo che si trovassero circondati dalle nostre ‘truppe’. Al grido di ‘Tora, Tora, Tora!’, lanciato dal capo designato, avvenne l’assalto: acqua e farina per tutti, pronti per finire in padella. Il colpo riuscì perfettamente, ma la reazione dei bocconiani fu piuttosto contrariata: noi tre sacerdoti presenti dovemmo faticare non poco a calmare gli animi … Passata la sfuriata, celebrammo la Santa Messa tutti insieme, avendo chiaro che in realtà ci volevamo veramente bene. Non tutti però i bocconiani furono subito convinti di questa grande verità: si recarono al nostro parcheggio e sgonfiarono tutte le gomme delle macchine targate Milano … La mia per fortuna era targata Trento!
L’ultima sera ci fu la tradizionale serata finale, piena di numeri di vario genere. Io e don Tomviulin, essendo l’uno alto e magro e l’altro medio e tarchiato, decidemmo di vestirci da Blues Brothers e suonare “Everybody needs Somebody”: la cosa più bella è stato lo stupore di tanti amici, pieni di letizia perché eravamo davvero tutti coinvolti in una grande amicizia.
Il Meeting in quegli anni non veniva molto sottolineato come gesto per il CLU, come invece avverrà a partire dalla metà degli anni Novanta. Però erano molti gli universitari che vi andavano e che facevano i volontari. Molti erano stati gessini e quindi si erano già affezionati al gesto riminese. Altri vi partecipavano perché invitati dagli amici. Pian piano l’amore al Meeting cresceva. Con il tempo apparirà più chiaramente il valore culturale, educativo e missionario eccezionale del Meeting, per cui il CLU sarà molto coinvolto anche concettualmente, soprattutto nella elaborazione delle mostre e nel lavoro di guida ad esse.
Le vacanzine-studio
La vacanza estiva e il Meeting non erano le uniche occasioni di compagnia comunitaria: durante l’anno ogni facoltà organizzava anche una ‘vacanzina-studio’ di tre o quattro giorni in montagna, in varie località lombarde, particolarmente all’Alpe Motta. Come sacerdote ero spesso richiesto dai vari gruppi di facoltà per accompagnare queste vacanzine per la celebrazione quotidiana della Santa Messa e per le confessioni: devo dire che è stata una delle esperienze più belle di quegli anni, da cui ho imparato molto. Si studiava, si stava insieme, si usciva all’aria aperta, si pregava, si cantava, si incontrava qualche amico più grande … si faceva esperienza, ancora una volta, di cos’è la fede e come cambia la vita. E c’erano sempre persone nuove che partecipavano e incontravano l’avvenimento di Cristo. Per me era edificante vedere come molti responsabili e molti volontari di segreteria si spendevano generosamente per realizzare bene il gesto comunitario. Non solo, ma anche gli altri della comunità si davano da fare per aiutare le persone nuove. Così la compagnia di Cristo si faceva sentire.
L’Happening in città
Prima di andare in vacanza si teneva verso la fine di giugno un grande evento pubblico in città, chiamato Happening, cioè sostanzialmente ‘avvenimento’. Era una festa di due o tre giorni, in qualche tensiostruttura comunale, con musica, piatti caldi, testimonianze, mostre e la Santa Messa domenicale. Anche in questo caso gli amici della comunità si prestavano per il volontariato o semplicemente per partecipare al gesto, il quale ancora una volta testimoniava il costante impegno del Movimento per la presenza pubblica dell’avvenimento cristiano. Era anche una ulteriore occasione per dedicare il proprio tempo libero per la gloria di Cristo nel mondo.
Le caritative, ovvero l’educazione alla gratuità
Un altro aspetto fondamentale della vita del CLU era la caritativa, ovvero l’educazione alla carità o gratuità. Un giorno alcuni amici della Cattolica mi hanno chiesto se potevo celebrare una Santa Messa per i clochard ospitati da Fratel Ettore negli androni sotterranei della Stazione Centrale di Milano: un gruppo di nostri studenti della Cattolica andava ogni settimana a fare la caritativa in quell’opera, dove il famoso frate lombardo faceva celebrare regolarmente la Santa Messa. Sono andato volentieri e mi sono reso conto ancora una volta della potenza della fede, vedendo la compagnia che Fratel Ettore aveva realizzato e l’umiltà e la delicatezza con cui i nostri studenti si mettevano al servizio di quella realtà in nome di Cristo.
Non era tuttavia che una delle tante caritative in cui la compagnia della Cattolica era coinvolta. Anzitutto c’era l’opera della CUSL (Cooperativa Universitaria Studio e Lavoro), che gestiva un punto vendita pubblico appena fuori dall’ateneo, dove si vendevano libri a prezzo scontato e si facevano fotocopie per tutti gli studenti. Era un’opera che chiedeva una notevole organizzazione e capacità amministrativa, perché il lavoro era molto, specialmente con le fotocopie (gli studenti portavano i libri e i nostri volontari facevano loro il lavoro di copiare e rilegare). Era un modo per aiutare tutti ad affrontare i costi dello studio. E si vendevano anche i libri del Movimento, difficilmente trovabili altrove. Non c’era ancora internet, all’epoca.
Un’altra caritativa molto impegnativa era quella del neonato Banco Alimentare, per opera del Cavalier Frassati e di don Giussani. I volontari dovevano confezionare i pacchi di alimenti, altri dovevano distribuirli alle famiglie povere della città, altri dovevano aiutare ai vari servizi amministrativi e di approvvigionamento. Un’opera molto grande, che nel giro di alcuni anni si estenderà a tutta Italia.
Va infine notato che, oltre a quelle citate, c’erano molte altre caritative, che ora non ricordo esattamente: con i bambini nelle parrocchie, nei ricoveri degli anziani, in varie opere di carità.
La caritativa richiedeva insomma la donazione di non poco tempo, che normalmente uno studente pensa ad utilizzare per i propri interessi di studio, di sport, di divertimento, di apprendimento delle lingue straniere, e così via. Il fatto invece che gli studenti universitari di CL sacrificassero parte del loro tempo prezioso per le opere caritative poteva sembrare controproducente o oppressivo rispetto all’urgenza della loro qualificazione intellettuale. Si verificava però l’opposto: quel sacrificio li rendeva più produttivi nel tempo-studio, più capaci di cogliere i punti fondamentali, più maturi umanamente e quindi anche intellettualmente, meno soggetti agli atteggiamenti noiosi tipici degli intellettuali. Non solo, ma grazie a quel tempo speso gratuitamente e contro i propri interessi, sono maturate persone che poi hanno saputo dare la vita intera per la comunità, per la loro famiglia, per i loro figli, per la Chiesa, per il bene di tante persone.
Tutti quelli che facevano la caritativa dovevano anche curare la coscienza del gesto, leggendo insieme un piccolo testo di don Giussani: bisognava avere chiaro il perché di tutto questo, per non fare uno sterile attivismo sociale. La carità è il livello più profondo e grande dell’amore, perché coincide con Cristo stesso: è Lui che fa sì che un pacco alimentare non sia solo una scatola di vivande, ma il segno di una comunione che abbraccia la nostra persona qui e per l’eternità.
La vita comunitaria negli appartamenti del CLU
Molti studenti di CL, come noi trentini, venivano da fuori sede e avevano bisogno di un alloggio. Sono nati così gli appartamenti de “La ringhiera”, un’altra opera di caritativa al servizio degli altri: venivano affittati alcuni appartamenti in città, dove trovavano posto 5 o più studenti, che dividevano la spesa e costituivano una piccola comunità domestica, nella quale c’erano i turni per le pulizie e per cucinare la cena comunitaria. Nel rispetto della libertà di ciascuno, in quanto erano ospitati a volte anche amici non del Movimento, veniva proposto a tutti un gesto di preghiera quotidiano, guidato dallo studente responsabile dell’appartamento. Non c’era promiscuità: ogni unità abitativa era maschile o era femminile.
C’era molta allegria in questi appartamenti e spesso venivano invitati altri amici a cena, specialmente in occasione di qualche dialogo importante o più semplicemente per vedere qualche partita in televisione. Ricordo anch’io le varie cene in queste piccole comunità dove continuava a vivere lo spirito della grande compagnia del CLU. Era sicuramente importante per noi sacerdoti accettare gli inviti e ricordo con gratitudine la gioia di questi giovani di ospitare un amico sacerdote e poter dialogare con lui a tutto campo.
I corsi di don Giussani in Cattolica
La comunità della Cattolica, rispetto a quelle degli altri atenei, aveva una grande risorsa in più, che altrove purtroppo non si poteva avere: i corsi universitari di Morale o Teologia che don Giussani teneva ogni settimana il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina. La Cattolica, infatti, aveva come regolamento per tutti gli studenti l’obbligo di sostenere tre esami di teologia/morale negli anni del corso di laurea. Tutti i ciellini cercavano di poter frequentare i due corsi tenuti da Giussani, anche se non c’era posto per tutti. Tuttavia queste lezioni erano così frequentate che l’università concesse l’aula magna, in grado di ospitare diverse centinaia di uditori. Così anch’io ho avuto la grazia di frequentare per tre anni ogni settimana le due ore del martedì.
Don Giussani svolgeva in questi corsi il suo ‘Percorso’ fondamentale, vale a dire il ‘trittico’ de 1) il senso religioso, 2) Gesù Cristo e 3) la Chiesa. Il primo punto è l’esigenza di verità, amore, giustizia e felicità che costituisce il cuore e la ragione dell’uomo e coincide con l’esigenza dell’Infinito, che è Colui che ci fa essere (“Tu-che-mi-fai”). Il secondo punto è l’incontro con l’Infinito che si è fatto Uomo in Gesù Cristo e solo risponde all’esigenza costitutiva. Il terzo punto è la continuità dell’avvenimento di Cristo dentro la compagnia dei credenti in Lui nella storia.
Questo trittico diventerà il testo fondamentale (in tre volumi) della Scuola di Comunità del Movimento dagli anni Novanta fino ad oggi. All’epoca era in svolgimento la prima pubblicazione dei tre volumi da parte dell’editrice Jaca Book. Chiaramente poter seguire questo percorso ascoltandolo ogni settimana dalla viva voce di don Giussani è stato un regalo straordinario e una risorsa formidabile per i giovani ciellini della Cattolica. Dispiace solo che all’epoca non sia stato possibile effettuare una videoregistrazione completa di queste lezioni, anche se tutti i loro contenuti sono esposti tali e quali nei tre volumi oggi stampati da Rizzoli e negli altri libri di don Giussani finora pubblicati (nel senso che egli infarciva il Percorso con qualche esempio o fatto o citazione aggiuntiva che poi è emersa anche nei dialoghi riportati dai suoi vari libri, soprattutto i cosiddetti “Tischreden” della BUR).
È impossibile calcolare i frutti che queste lezioni hanno portato: centinaia, o meglio migliaia di persone hanno potuto acquisire in esse una coscienza dei contenuti e delle ragioni della fede che ha segnato indelebilmente la loro vita e la loro azione nella società. Questa coscienza è determinante: senza di essa il Cristianesimo rimane un tesoro nascosto e inutilizzato.
Le Equipe del CLU
Il cuore di tutta questa grande compagnia - intesa non solo come comunità della Cattolica, ma come l’intero CLU presente nelle varie università italiane - era il gruppo degli studenti responsabili che si riuniva regolarmente con don Giussani, insieme anche ad alcuni docenti universitari del Movimento. Quando uno studente dimostrava di vivere con intensità e verità la proposta del CLU, veniva chiamato a far parte di questo gruppo, che aveva assunto il nome di ‘Equipe del CLU’. Si trattava di un numero variabile di partecipanti, che passò gradualmente da duecento a settecento mano a mano che il CLU si diffondeva anche a livello internazionale. La cosa sorprendente è che si riuniva tre volte all’anno in convegni della durata di tre o quattro giorni ciascuno, avendo come appuntamento principale quello di fine agosto in montagna.
Don Giussani aveva ben chiaro il principio che le persone che animavano le comunità dei vari atenei andavano seguite con cura, con metodo, con serietà e con dedizione. Non sarà mai sottolineato abbastanza il valore di questo principio. Un movimento o una comunità o una realtà ecclesiale abbandonata al suo spontaneismo o a vampate saltuarie di idee e di proclami o a una cura blanda e stantia o alla smania delle novità e dello sperimentalismo, non può che sfaldarsi o tirare avanti senza vita e senza spirito. Benché sia stato un uomo carismatico, quello di don Giussani è stato anche se non soprattutto il lavoro del contadino, che con pazienza e metodo coltiva la terra costantemente e raccoglie i frutti a suo tempo.
Bisogna chiedersi se oggi nelle nostre comunità cristiane esiste questa cura sistematica. Senza di essa la vera fede rimane inapplicata e quindi non sperimentata. Basta leggere le lettere di San Paolo per vedere con quanta cura egli seguiva le sue comunità cristiane e le singole persone che le componevano, con l’aiuto di collaboratori scelti, mandati con premura e regolarità in tutte le città in cui era stata fondata una comunità.
Così faceva don Giussani, non soltanto con il CLU. Per noi sacerdoti egli teneva ogni mese e mezzo tre raduni: uno a Milano, uno a Bologna e uno nel centro-sud. Per almeno dieci anni io ho potuto partecipare ogni mese e mezzo al raduno di Bologna insieme ad altri 150 confratelli del nord-est: al mattino c’era una assemblea di due ore sui contenuti fondamentali guidata da don Giussani; poi si pranzava insieme; nel pomeriggio una seconda assemblea su una questione socio-culturale, con l’aiuto non solo del Giuss ma anche di alcuni sacerdoti esperti. Non ci sono parole per dire quanto sia stato utile avere questo punto di riferimento per la nostra vita sacerdotale e per la nostra missione pastorale.
Allo stesso modo don Giussani seguiva i Memores, cioè le persone consacrate, con ritiri ed esercizi spirituali regolari più volte all’anno. E lo stesso dicasi con la Fraternità, cioè con i ciellini diventati adulti dopo gli anni dell’università.
Nell’insieme un lavoro enorme, che il fondatore portava avanti senza mai esimersi dal dovere di sostenere le persone che Dio gli aveva consegnato, finché le forze glielo hanno permesso. Dal 1992 al 1998 ha dovuto gradualmente diradare gli incontri, fino al ritiro definitivo, durante il quale però ha continuato a lavorare per la compagnia del Movimento e a farsi sentire con qualche audio e video.
Tornando alle Equipe del CLU, esiste oggi una eccezionale documentazione del lavoro che è stato svolto in esse grazie alla pubblicazione in otto volumi, curati da don Carrón, del testo delle lezioni ivi svolte da don Giussani e dei suoi dialoghi assembleari con gli studenti. La lettura di questi volumi è tutt’altro che noiosa: da essi emerge impetuosa la presentazione dell’avvenimento cristiano e della sua presenza nelle università, con un linguaggio e una acutezza che non hanno nulla di scontato o di consueto. Leggendoli si capisce quale era e quale è il cuore di questa compagnia e la ragione per cui è stata ed è ciò che sopra si è descritto. Una realtà stupefacente come quella che si è narrato finora può nascere solo dalla decisione di vivere l’appartenenza a Cristo; le Equipe avevano esattamente questo scopo: lanciare se stessi e gli altri nell’avventura della sequela reale di Cristo. Don Giussani era totalmente coinvolto in questa decisione e nulla poteva fermarlo: era questa sua fede indomita che ha permesso a tutti gli altri di fare l’esperienza che hanno fatto.
“Guarda come si vogliono bene”
In occasione del Santo Natale del 1987 o 1988 i responsabili della comunità della Cattolica chiesero a don Giussani di celebrare una Santa Messa verso il 20 di dicembre per tutti i nostri universitari nella Basilica di Sant’Ambrogio, adiacente all’ateneo. Fu un gesto notevole, per la bellezza del luogo, della compagnia numerosissima di giovani, per i canti e per le parole del don Giuss, oltre che per la potenza del Sacramento Eucaristico. Durante l’omelia egli ha fatto un’osservazione che mi è rimasta nella memoria. Rivolgendosi agli studenti disse più o meno così: “È così bella la compagnia che Cristo realizza tra voi che, se la vivrete con fedeltà, guardandovi tutti diranno: ‘Guarda come si vogliono bene!’. E questo li attirerà a Cristo”.
Aveva colto un fatto reale, di cui non posso non dare testimonianza: ci si voleva bene, davvero, per Cristo e in Cristo. Con l’umiltà di chi sa di essere bisognoso di tutto.
La generazione di famiglie cristiane, persone consacrate e sacerdoti
Dalla comunità della Cattolica di quegli anni sono venuti frutti notevoli per la Chiesa e per il mondo. Terminata l’università, non pochi sono entrati in seminario e sono diventati sacerdoti: don Paolo Sottopietra, don Antonio Anastasio, don Gianluca e don Fec (Fecondo) con la Fraternità Missionaria San Carlo; don Giorgio Paximadi nella Diocesi di Lugano e don Enrico nella Diocesi di Verona. Molti altri ed altre sono entrati a far parte dei Memores Domini, consacrando la loro vita interamente a Cristo in questa nuova forma di monachesimo urbano. Infine la gran parte si sono consacrati a Cristo attraverso il Sacramento del Matrimonio, dando vita a quella schiera notevolissima di famiglie cristiane unita nella Fraternità di CL che tutti conosciamo. Va sottolineato il fatto che la Fraternità ha permesso a queste famiglie di continuare la stessa esperienza del CLU dentro la vita adulta, con l’impegno per la Scuola di Comunità, la S. Messa settimanale della comunità, la presenza della compagnia nei posti di lavoro, la costruzione della Compagnia delle Opere, la diffusione della cultura che nasce dalla fede e che si esprime nelle pubblicazioni del Movimento, l’operosità nelle varie opere caritative (soprattutto il Banco Alimentare e le Famiglie per l’Accoglienza), il lavoro per il Meeting, l’educazione dei figli, la preghiera personale e comunitaria, le vacanze insieme, i ritiri, gli Esercizi nazionali annuali, i Centri Culturali, la missione nel mondo. I quattro o cinque anni dell’università non sono stati un fuoco di paglia, ma una parte del cammino verso la pienezza della comunione.
La preghiera di Gesù per il CLU
Il nesso di tutto questo con il Vangelo è espresso nel modo più sublime dalla preghiera che Gesù ha rivolto al Padre al termine dell’Ultima Cena subito prima di uscire dal Cenacolo per andare alla Passione (è tutto il capitolo 17 di Giovanni). In quella preghiera Egli ha evidentemente detto le cose che più gli stavano a cuore, come culmine di tutto il suo insegnamento agli Apostoli. Ebbene, le parole di quella preghiera non riguardano solo i suoi Apostoli, ma tutti i cristiani, come Gesù dice esplicitamente. Esse perciò andrebbero lette avendo davanti agli occhi i volti della compagnia in Cristo che ci è stata data. Leggendole in riferimento a quegli ottocento della Cattolica mostrano a me in modo impressionante la verità e la bellezza della fede.
Sì, tutto quello che Gesù dice della compagnia dei suoi discepoli, è riferito a noi. Egli ha a cuore questa compagnia, per essa si consacra affinché sia consacrata nella verità, per essa dona la sua vita, per essa chiede la vita eterna, che coincide con la conoscenza dell’Infinito che è il Padre ed Egli stesso.
Gesù chiede che siamo una sola cosa nella Trinità Divina così che il mondo veda e creda: troppo spesso abbiamo ridotto questa richiesta ad un sentimento vago e disincarnato; no, Gesù parla di un’unità di cui si fa esperienza; è un’unità che i cristiani devono vivere lì dove sono, in un’amicizia reale, visibile, sperimentabile, nella vera fede.
Questa preghiera è la sintesi di tutto quello che abbiamo detto, è il manifesto della Chiesa Cattolica, è il metodo della sua missione, è la verità ultima di ogni comunità cristiana autentica. Forse è venuto il momento in cui ogni cristiano la reciti ogni giorno, per chiedere la grazia di vivere veramente la Chiesa lì dove siamo.
Ed ecco la Città
“Ed ecco la Città, con le sue mura d’oro, le sentinelle sulle torri, fiorita d’alberi e giardini. Io non l’avevo vista mai, eppure c’ero nato, ed era quella la Città dove sarei tornato”. Queste parole di una bella canzone di Claudio Chieffo (“Il viaggio”, racconto autobiografico del suo incontro con Cristo nella compagnia del Movimento), colgono perfettamente il cuore della questione. Ciò che abbiamo descritto, seppure in modo molto misero rispetto alla potenza della realtà in oggetto, è semplicemente questo: la Chiesa. È essa la Città di cui parla Chieffo e di cui parlano i Salmi, come si è citato all’inizio: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei.
Quella compagnia di ottocento universitari della Cattolica altro non era e non è che questo: la Chiesa, la Città amata. Guardandola, si capiscono le parole da brivido con cui la descrive San Pietro Apostolo: “Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia” (1 Pt 2).
Un tempo eravate non-popolo: eravate quello che è l’umanità occidentale di oggi, un insieme di uomini soli, perché rimasti senza Dio e senza comunità, se non quella di chi convive nell’estraneità. Ora invece siete popolo di Dio: ora siete la compagnia di Cristo, la sua Chiesa, una sola cosa in Lui.
Quando questo popolo appare, è come se improvvisamente facesse capolino il sole in un giorno di pioggia. Quando questo popolo viene costruito misteriosamente dallo Spirito, allora appare ciò che è: un miracolo.
Conclusione: lo stupore e l’umiltà di imparare
In conclusione mi permetto di sottolineare questo termine: miracolo. Don Giussani affermava che questo termine è centrale nel Cristianesimo, come dice lo stesso San Paolo: “Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all’obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito” (Rm 15); “La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio” (1 Cor 1). Il Cristianesimo dimostra la sua verità nel miracolo: non solo in quello della guarigione di un infermo, ma ancor più in quello di una compagnia che per il mondo è impossibile.
In effetti la compagnia di quegli ottocento giovani è una realtà impossibile per il mondo: non si trova da nessuna parte. Nessuna ideologia è mai riuscita a realizzarla. Nel Sessantotto i più utopisti sognavano di fare una cosa simile, ma non ci sono mai riusciti. La ragione è evidente: se non è una compagnia con Cristo e in Cristo, che è il Tu-Infinito che ci fa essere e per cui siamo fatti, niente e nessuno può farci essere una sola cosa, anche perché non servirebbe a nulla esserlo lì dove tutto è destinato alla morte.
La compagnia cristiana, quando è vissuta con autenticità, è sempre un miracolo. Tale è stata innumerevoli volte nella storia, secondo tutte le forme che lo Spirito ha suggerito. Oggi per far sì che i giovani incontrino Cristo lì dove vivono e formano la loro mente e il loro cuore, cioè nei licei e nelle università, lo Spirito ha dato a don Giussani il carisma necessario per dare vita alle comunità cristiane di studenti. Se si ha un minimo di umiltà di fronte ai doni dello Spirito - riconosciuti tali dalla Chiesa -, bisogna avere la volontà di imparare da essi quello che si deve vivere e fare.
