Esaltazione della Croce - 14 settembre
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:

Dopo che tutto il clero e una gran moltitudine di popolo si sono radunati… tre dei maggiori dignitari (del Capitolo) … vengono a poco a poco portati in alto mediante invisibili macchine, in un abitacolo… il quale per i lumi che si trovano all’interno offre l’aspetto di una nuvola splendentissima». (Carlo Bascapè) (Immagine 1)
Certamente la festa dell’Esaltazione della Croce è importante in tutto l’orbe cristiano, ma nel Duomo di Milano tale festa ha una liturgia particolare. Poiché tale festa può variare nei giorni della settimana, la liturgia ambrosiana la sposta al sabato successivo a tale data e il tutto ha inizio con la solenne celebrazione dei Vespri e il Rito della Nivola, con cui si da avvio al Triduo del Santo Chiodo. (Immagine 2)
Il Santo Chiodo, importante Reliquia della Passione del Signore, è conservato nell’attuale Duomo dal 20 Marzo 1461, quando venne solennemente traslato dall’antica basilica “estiva” di Santa Tecla, ormai in via di demolizione, nella nuova e più grande Cattedrale, ancora in costruzione nell’area già occupata dalla basilica “invernale” di Santa Maria maggiore. (Immagine 3/4)
Ambrogio e il Santo Chiodo
Il primo accenno al Santo Chiodo che noi conosciamo è contenuto in un discorso di sant’Ambrogio, nell’orazione funebre tenuta in memoria dell’amico e imperatore Teodosio il 25 febbraio 395. In quell’occasione il vescovo spiegò come la madre di Costantino, sant’Elena, durante un suo viaggio in Terrasanta, rinvenne per ispirazione divina non solo la croce, ma anche i chiodi che erano serviti alla crocefissione. Con due di essi volle forgiare dei simboli assai particolari, da donare al figlio imperatore affinché governasse con giustizia e con l’aiuto di Dio. Uno dei chiodi fu dunque modellato come un «freno» (cioè un morso di cavallo), l’altro a mo’ di diadema (ovvero una sorta di corona). Entrambi questi segni distintivi furono poi tramandati da Costantino ai suoi successori, fino appunto a Teodosio.
E’ da notare che il racconto del rinvenimento dei Santi Chiodi è riportato in forma pressoché identica anche da altri scrittori, storici e uomini di Chiesa dell’epoca, le cui osservazioni fanno comunque pensare che con un solo Santo Chiodo non sia stato fatto, ad esempio, un solo morso di cavallo, ma più d’uno , «tutti ugualmente valorizzati col frazionare in ciascuno una parte del prezioso ferro»; era infatti consuetudine "moltiplicare" le reliquie con l’unione di una piccola parte autentica ad un facsimile della reliquia vera, oppure anche semplicemente con il contatto..
La pia tradizione vorrebbe che il Santo Chiodo custodito in Duomo sarebbe stato dato al vescovo milanese dallo stesso Teodosio, e in esso andrebbe riconosciuto proprio quel sacro ferro trasformato in freno. Ma va anche detto che nessuna fonte storica nè alcun documento oggi a nostra conoscenza può confermare tutto ciò. Per questo vari studiosi hanno formulato altre ipotesi.
Altre ipotesi
Lo storico Sassi pensa che il Santo Chiodo sia giunto nel capoluogo lombardo dall’impero di Bisanzio attorno all’VIII secolo, salvato da qualche viaggiatore durante la furiosa lotta iconoclasta. Altri ritengono invece che la reliquia sia stata portata a Milano da quello stesso vescovo milanese Arnolfo II che aveva già fatto sistemare nella basilica di sant’Eustorgio i corpi dei Magi.
Il Fumagalli, infine, e con lui altri ricercatori, ipotizza che il sacro ferro sia stato donato alla Chiesa milanese da alcuni crociati di ritorno dalla Terrasanta . Nessuna di queste ipotesi, comunque, pare poter prevalere sulle altre, e soprattutto nessuna sembra in grado di sminuire quanto affermato dalla tradizione milanese in merito al Santo Chiodo.
Di certo, invece, si sa che la reliquia si trovava nell’antica cattedrale milanese prima del 1369, anno in cui una precisa testimonianza ricorda come da tempo immemore («ab antiquo») il Santo Chiodo fosse posto in Santa Tecla, in un reliquiario a forma di croce, posto su una tribuna al di sopra dell’altar maggiore.
La devozione con san Carlo Borromeo
La devozione al Santo Chiodo non è mai venuta meno nel popolo ambrosiano, ma essa venne particolarmente valorizzata e incentivata dall’arcivescovo Carlo Borromeo. In occasione della peste del 1576, egli portò in processione la preziosa Reliquia per le strade di Milano e inaugurò il suggestivo rito della Nivola. (Immagine 5/6/7/8)
Volle infatti che la Processione con il Santo Chiodo fosse ripetuta ogni anno il 3 Maggio, festa del Ritrovamento della Santa Croce, secondo l’antico calendario liturgico. L’attenzione dei fedeli si concentrava tuttavia sul momento iniziale della cerimonia, quello del prelevamento della insigne Reliquia. Essa infatti era – ed è tuttora – conservata in un tabernacolo (sempre segnalato da una lampada rossa) posto sulla sommità della volta interna del Duomo, in luogo eminente e inaccessibile se non con quella particolare “macchina” detta appunto Nivola. Con questo nome, derivato dal dialetto milanese, si designa una sorta di “ascensore”, a forma di nuvola e decorato con tele dipinte, statue di angeli e drappeggi (risalente nella sua forma attuale al 1624), unico mezzo con il quale è possibile raggiungere il tabernacolo del Santo Chiodo. Sempre attraverso la Nivola, la preziosa Reliquia veniva ricollocata nel suo tabernacolo al termine delle celebrazioni che duravano fino al 5 Maggio. Più volte restaurata, l’attuale struttura della Nivola è interamente rivestita di tela dipinta con figure di angeli, opera di Paolo Camillo Landriani detto il Duchino, che agli inizi del Seicento eseguì diverse opere per la Veneranda Fabbrica del Duomo, a cominciare da alcuni «quadroni» delle celebri serie che illustrano la vita e i miracoli di san Carlo. (Immagine 9/10)
In origine, e fino agli anni Sessanta del secolo scorso, azionata a mano grazie a funi e carrucole, oggi la «nivola» è mossa da un motore elettrico.
Il rito del Santo Chiodo oggi
Oggi, con il nuovo ordinamento liturgico, la festa del 3 Maggio in onore della Croce è stata soppressa e quindi il Triduo del Santo Chiodo, con il rito della Nivola è stato opportunamente ripristinato, anche a seguito del complesso e lungo lavoro di consolidamento del tiburio, attraverso la sua collocazione nei tre giorni (sabato, domenica e lunedì) più vicini al 14 Settembre, festa dell’Esaltazione della Santa Croce. In tale occasione, all’inizio dei Vespri del sabato, grazie alla Nivola viene prelevata la teca contenente la preziosa Reliquia, che viene mostrata al popolo inserita in una grande croce di legno dorato. La Processione, che ai tempi di san Carlo dal Duomo giungeva fino alla vicina chiesa di San Sepolcro (situata nell’omonima piazza), oggi si tiene esclusivamente all’interno della Cattedrale, al termine dei Vespri della domenica. Infine, la sera del lunedì, con una nuova “ascensione”, il Santo Chiodo viene ricollocato nel suo tabernacolo che incombe dall’alto sull’altare e su tutta la Cattedrale.
La Reliquia
Il prezioso cimelio si presenta composto da tre elementi: un primo, costituito da una tonda verga di ferro, piegata ad anello alle due estremità, a forma di morso o freno: il Santo Chiodo vero e proprio: un grosso ferro forgiato a mano, a sezione quadrano per cavallo; un secondo, consistente in una più sottile verga di ferro, a sezione circolare, ripiegata su se stessa e al termine attorciliata in quattro cerchi assai irregolari, si tratta forse di una aggiunta per maneggiare la reliquia senza toccarla; infine un terzo e più importante: il Santo Chiodo vero e proprio: un grosso ferro forgiato a mano, a sezione quadrata, con la punta ripiegata ad uncino entro un anello del morso, e dalla parte opposta ingrossato a formare la “testa” di un grosso chiodo. La reliquia era dunque un pendaglio attaccato al morso. (Immagine 11) La teca in cui la Reliquia è conservata è di cristallo di rocca, argento e pietre preziose, donata dal cardinal Federigo Borromeo attorno al 1624. (Immagine 12)
I quadri con le Storie della Croce e del Santo Chiodo
In occasione della festa della Croce il Duomo era tutto sontuosamente addobbato. Particolare splendore conferivano alla cattedrale i 22 grandi quadri che nell'occasione erano esposti tra i piloni: un mirabile ciclo di tele – sette delle quali andate perdute – raffiguranti episodi delle storie del ritrovamento della Croce e delle vicende del Chiodo. Questi i soggetti delle tele, secondo l'ordine in cui vennero elencati per la prima volta da Pietro Antonio Frigerio nella sua celebre descrizione del Duomo e con l'indicazione dell'attuale collocazione delle tele superstiti. I documenti relativi a tale ciclo sono molto rari, infatti non si sa il motivo per cui le tele vennero offerte dalle Università professionali e dalle Corporazioni d’arte e mestiere, tanto che le tele erano conservate durante l’anno presso la cappella a cui la corporazione faceva riferimento. (Immagine 13)
Ecco le tele:
1. A Costantino appare la croce col motto "In hoc signo vinces", di Pietro Paolo Pessina. (Immagine 14)
2. Costantino al concilio di Nicea raccomanda a san Macario di cercare la croce, di anonimo lombardo. (Immagine 15)
3. Sant'Elena è avvertita in sogno da un angelo, di Pietro Maggi, offerto dalla corporazione dei mercanti di Lione. (Immagine 16)
4. Costantino provvede sant'Elena dell'occorrente per il viaggio in Terra Santa, del Bellotto, offerto dalla corporazione degli offellari (disperso).
5. Sant'Elena, giunta a Gerusalemme, è ricevuta dal vescovo san Macario, di Antonio Lucini. (Immagine 17)
6. San Macario e sant'Elena sono ispirati circa la ubicazione del luogo dove si trova la croce, di ignoto, offerto dalla corporazione degli osti (disperso).
7. Sant'Elena fa distruggere la statua di Venere eretta sul Calvario, di T. Formenti detto Formentino (disperso).
8. Sant'Elena alla presenza di san Macario fa scavare nel terreno e ritrova le tre croci, di G. Battista Barbesti, offerto dalla corporazione dei calzolai. (Immagine 18)
9. Il miracolo del morto risuscitato dal contatto con la vera croce, di Andrea Lanzani, offerto dalla Camera dei mercanti di seta. (Immagine 19)
10. La guarigione istantanea di un'inferma al contatto con una delle tre croci, offerto dalla corporazione dei filatori, di anonimo lombardo. (Immagine 20)
11. Sant'Elena e san Macario venerano la croce e i sacri chiodi, di certo Sampietro. (Immagine 21)
12. Il ritrovamento del Santo Sepolcro e dei Sacri Chiodi, di Carlo Preda (disperso).
13. Sant'Elena, sorpresa da tempesta nell'Adriatico, immerge in mare uno dei sacri chiodi, di Francesco Fabbrica, offerto dalla corporazione dei cordai. (Immagine 22)
14. Sant'Elena indica a san Macario quale parte di croce desidera venga destinata all'erigenda basilica del Santo Sepolcro, del Ferroni (disperso).
15. Un fabbro trasforma il Chiodo in un freno, che viene benedetto da un sacerdote, di Pietro Maggi, offerto dalla corporazione dei fabbri. (Immagine 23)
16. L'imperatore Giustino, tormentato nel sonno dai demoni, ne è liberato dalla presenza del Chiodo, di Andrea (o Ferdinando?) Porta. (Immagine 24)
17. Elena offre a Costantino il freno e il diadema ricavati dai sacri chiodi, di Tommaso Formentino, offerto dalla corporazione degli orefici. (Immagine 25)
18. Costantino, che reca la croce rivestito degli abiti imperiali, è fermato da angeli finché non li abbia deposti, di Carlo Preda, offerto dalla corporazione dei droghieri. (Immagine 26)
19. Eraclio costringe Siroe a restituire la croce, di Pietro Antonio Magatti, offerto dalla corporazione dei merciai. (Immagine 27)
20. Siroe re di Persia restituisce la croce ad alcuni schiavi, del Formentino, offerto dalla stessa corporazione. (Immagine 28)
21. Lo stesso episodio, elaborato in forma diversa da Antonio Maria Ruggeri (disperso).
22. San Carlo reca il processione il Santo Chiodo durante la peste, del Pessina, offerto dalla corporazione dei cervellari (disperso).
Tutte queste tele furono eseguite anteriormente al 1739, anno in cui vide la luce l'opera del Frigerio. Alcuni dipinti erano già pronti nel 1708, e per la prima volta vennero in quell'anno esposti in Duomo. Così il cerimoniere dava notizia della grande novità dell'apparato in cattedrale: "In domo quest'anno si è fatto un apparato sontuosissimo con l'esposizione di alcuni quadri preziosi donati dalle università [le corporazioni] di Milano, quale apparato si andrà accrescendo per l'avvenire a gloria del Signore".
In occasione del Giubileo del Duemila la Veneranda Fabbrica ha disposto una ricognizione e un restauro del ciclo pittorico, gran parte del quale da troppo tempo tenuto nascosto ai fedeli e in precarie condizioni di conservazione perché chiuso nei depositi sopra la sagrestia meridionale della cattedrale. In occasione delle feste della Croce era esposto sulla porta centrale del Duomo anche il grande quadro rappresentante la Gloria del Santo Chiodo, posto nella croce processionale sostenuta da angeli in volo. La tela, risalente all'ultimo scorcio del Seicento, non fa parte del ciclo pittorico sopra citato. Continuò ad essere esposta per le feste della Croce anche quando per il deperimento e la dispersione di alcuni quadri, non si esponeva più l'intero ciclo dei quadroni. Anche sulla facciata della chiesa del Santo Sepolcro era appesa per l'occasione una bella tela rappresentante i santi Ambrogio e Carlo in adorazione del Santo Chiodo racchiuso nella sua custodia a forma di croce sorretta da angeli. Altri quadri erano esposti lungo il percorso della processione. Il Corno afferma che nel 1628 in contrada Pescheria Vecchia, sotto la porta della piazza dei Mercanti, fu rappresentata la scena del ritrovamento del Chiodo da parte di sant'Ambrogio nella bottega d'un mercante di ferri di cavallo, e che poi in quello stesso luogo si esponeva costantemente un quadro raffigurante san Carlo parato pontificalmente in adorazione della Sacra Reliquia. (Immagine 29)
 Immagine 1
Immagine 1 Immagine 2
Immagine 2 Immagine 3
Immagine 3 Immagine 4
Immagine 4 Immagine 5
Immagine 5 Immagine 6
Immagine 6 Immagine 7
Immagine 7 Immagine 8
Immagine 8 Immagine 9
Immagine 9 Immagine 10
Immagine 10 Immagine 11
Immagine 11 Immagine 12
Immagine 12 Immagine 13
Immagine 13 Immagine 14
Immagine 14 Immagine 15
Immagine 15 Immagine 16
Immagine 16 Immagine 17
Immagine 17 Immagine 18
Immagine 18 Immagine 19
Immagine 19 Immagine 20
Immagine 20 Immagine 21
Immagine 21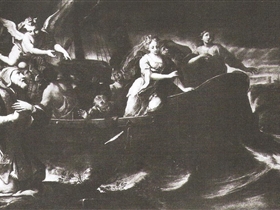 Immagine 22
Immagine 22 Immagine 23
Immagine 23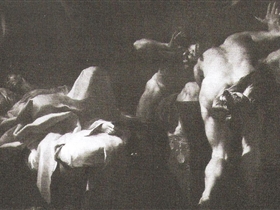 Immagine 24
Immagine 24 Immagine 25
Immagine 25 Immagine 26
Immagine 26 Immagine 27
Immagine 27 Immagine 28
Immagine 28 Immagine 29
Immagine 29
