Campagner, Luigi - Fiabe per pensare
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
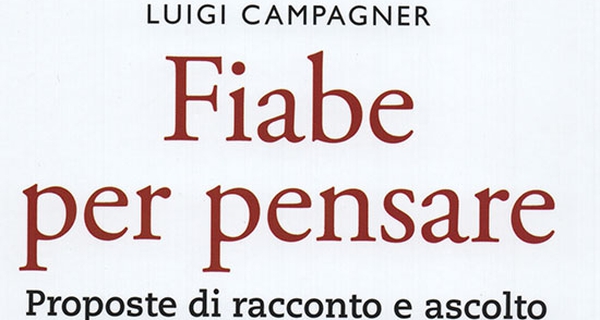
È una proposta, quella che ci fa Luigi Campagner, psicoterapeuta di stampo freudiano, con questo libro. Ci invita infatti a riconsiderare con uno sguardo nuovo i racconti orali, scritti e audiovisivi (cartoon) che ci hanno accompagnato nella nostra fanciullezza. Cenerentola, Pollicino, Cappuccetto rosso, Il gatto con gli stivali e le tante altre fiabe, sono racconti seri, raccolti e trascritti tra il 1600 e il 1800, prevalentemente dai famosi Perrault, Andersen e Grimm, che non erano scrittori per bambini, ma letterati colti e famosi. Scrivevano per un pubblico adulto e con sottili metafore tramandavano un sapere antico sulla vita e sul mondo: parlano tuttora a chi li vuole ascoltare. I significati reconditi delle fiabe educano inconsciamente chi le ascolta soprattutto quando è piccolo, in formazione e ha desto lo stupore. Per questo fiabe considerate oggi “tabù” come Barbablù, non sono diseducative, ma mettono in allerta chi le ascolta a non fidarsi di chi ha la “barba blu”, ossia qualche cosa di pericoloso nella sua vita: consiglia la prudenza. Il bambino può gettarsi nei rapporti con gli altri, ma deve tener presente che ci può essere qualcuno di “cattivo”, che potrebbe fargli anche involontariamente del male, e riconoscerlo.
D’altro lato le fiabe si concludono sempre con un lieto fine, quindi avvisano il bambino che anche nel caso lui sbagli a giudicare una persona o una situazione e finisca nei pasticci, verrà in suo aiuto una presenza benigna, fate madrine o animali fatati, principi azzurri o saggi maghi, e se seguirà i loro consigli, spesso ricchi di condizioni e contraddizioni, riuscirà a cavarsela.
Questo libro insomma, ci mostra con l’analisi di alcune delle fiabe più famose, l’uso intelligente che possiamo farne con i bambini con cui abbiamo a che fare, in primis con quel bambino che siamo stati noi. Anche il rapporto con chi racconta è importante per chi ascolta: in questo i primi a tramettere tanto al bambino sono naturalmente i genitori, che oltre i contenuti della fiaba trasmettono anche il loro personale giudizio su di essa e il loro legame affettivo con chi gliela raccontava a sua volta. Si crea così un legame intergenerazionale che fa capire qualcosa al figlio di come dovevano essere suo babbo o sua mamma quand’erano bambini a loro volta, e che rapporto avevano con i loro genitori. Non perdere la fanciullezza dello sguardo, lo stupore, la freschezza e la semplicità che caratterizzano i nostri primi anni di vita, è fondamentale per non perdere la strada di casa, come i ciottoli bianchissimi che Hansel e Gretel si lasciavano cadere dietro le spalle per ritornare alla casa padre.
Prendersi del tempo per rileggere le fiabe classiche e raccontarle con quella novità che ci caratterizzava quando a nostra volta le abbiamo udite la prima volta, può essere un piccolo mattone che edifica il rapporto con le nuove generazioni, piuttosto che affidarci a squallide invenzioni che appiattiscono tante volte la realtà stessa e nelle quali noi per primi non ci riconosciamo. Noi non possiamo che trasmettere quanto abbiamo ricevuto e integrato, sia come cognizioni che come certezze affettive. La novità è accorgersi tutte le volte che ciò che siamo, ciò che ci ha formato, è tuttora operante attraverso noi anche sugli altri.
