Cipriani, Elisabetta - Memorie da una casa viva
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
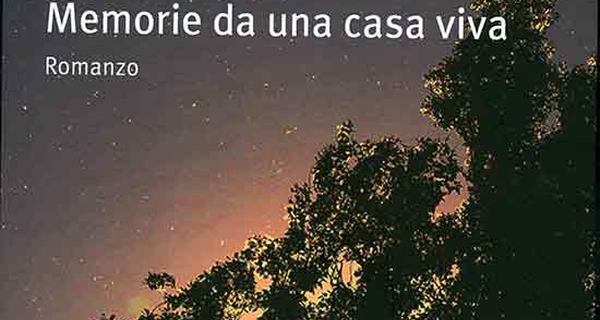
L’incipit del secondo romanzo di Elisabetta Cipriani (Memorie da una casa viva, Besa 2014) ci proietta nel mondo della scuola, colorando il testo di notazioni autobiografiche. L’Autrice infatti è insegnante (e “scrittrice per vocazione” come lei stessa si definisce), ed ogni autentico docente non fa fatica ad attingere a piene mani al proprio vissuto carico di drammatici incontri umani. La protagonista del romanzo, Ilaria Folli, è una professoressa il cui nome manifesta da un lato letizia, dall’altro un pizzico di pazzia: del resto il primo romanzo dell’Autrice (2008) aveva per titolo “I temerari”, e l’ardimentosa sconsideratezza sembra essere la cifra dei personaggi prediletti da Elisabetta Cipriani: persone che rischiano per essere all’altezza della propria umanità. Lo sfondo della storia è drammatico: in un futuro imprecisato ma non molto lontano dal nostro presente, il mondo è dominato da una casta di “tecnotrofi” supportati dall’Impero del Dragone. Alla gente comune non resta che l’evasione sempre più estrema di tecnologie alienanti, proiezione da cyborg degli odierni gadget informatici; oppure la rivolta disperata dei neoluddisti, No-TAV all’ennesima potenza, ribelli alle macchine nel nome di una società selvatica e primitiva.
Nel cuore di uno scontro tra neoluddisti e forze dell’Ordine, si ritrovano temerariamente in una scuola per un ripasso in vista dell’esame l’insegnante Ilaria Folli e quattro dei suoi alunni. La giornata rischia di concludersi prematuramente nell’imbarazzo generale, ma Ilaria se ne esce con una proposta: “Nessuno ha delle storie da raccontare?”. Sì perché “la vita di ognuno è una storia da raccontare”, come afferma Alessandro Zaccuri nella Postfazione: purché siano storie di uomini, non di belve né di automi. E allora prende il via un inatteso carosello di tipi umani, come quello delle “Memorie da una casa di morti” di Dostoevskij, non a caso citato a rovescio nel titolo del romanzo.
Marco, detto Stormymark, di professione writer-jockey, ossia propinatore di messaggi consolatori con musica incorporata da un sito internet per cuori solitari, prende coscienza della propria finzione e con gli occhi pieni di lacrime riscopre il silenzio delle stelle.
Rasta Joel, avviato su strade trasgressive ma patologicamente incapace di rapporti veri, porta all’estremo il suo sguardo cinico sulla vita e tenta di “liberare” sé stesso e il proprio fratello demente con due cappi appesi ad una quercia.
E poi il mitico studente cinese di fronte alla colonna dei tanks di Piazza Tienanmen; e Iulia, in lotta per la libertà propria e dei propri figli in una dittatura angosciante e spietata; e Sara, anoressica bisognosa della presenza amorosa di qualcuno che le “soffra accanto”. E infine il grande Michelangelo sul letto di morte, colto nel momento di trarre un bilancio della propria vita. Proprio mentre fuori i neoluddisti stanno per irrompere nella scuola abbattendo i cancelli e fracassando le finestre a sassate.
Elisabetta Cipriani, alla scuola dell’amato Dostoevskij, non ha timore di affondare le mani in una materia dolente e sanguinante, non si ritrae di fronte a nessuna piaga, alla ricerca del volto umano e dell’immutabile cuore che ogni persona ha dentro di sé.
Il futuribile mondo ipertecnologico, sull’orlo di una guerra civile, è in realtà il nostro presente dove sempre stridono le contraddizioni dell’esistenza, ma dove nelle persone vive le domande non sono estinte.
Quasi per un tacito accordo, le storie raccontate “sono inconcludenti, non si sa mai come va a finire”, come afferma uno degli studenti. Non vi è fretta di archiviare, o consolazione del lieto fine, ma si lascia a un Altro l’ultima parola: “Chi può dire cosa spunterà?”, afferma la vecchia contadina rumena della storia di Iulia buttando i semi nell’orto.
E non a caso, con un salto temporale, spaziale e narrativo che può apparire vertiginoso, entra in scena sul finire Michelangelo morente; proprio lui che aveva fatto dell’incompiuto la cifra di molte sue sculture: “L’uomo non ha scampo, se l’infinito stesso non lo soccorre”.
Anche l’Autrice scolpisce i suoi ritratti con nitore adamantino, ma pure lei li lascia incompiuti; come afferma la critica d’arte Miriam Leonardi parlando della Pietà di Palestrina, “La materia non è più un ostacolo, una prigione, ma viene salvata interamente nella sua incompiutezza, perché il compimento è di un Altro”.
