Promemoria per la Conferenza Episcopale Tedesca
«Ci permettiamo di presentarLe in allegato alcune riflessioni e considerazioni sull’attuale situazione nella chiesa cattolica, pregandoLa di sottoporle ai membri della conferenza episcopale tedesca.Le nostre riflessioni sono maturate dopo anni di attività scientifica sulla storia della chiesa e sono state dettate dalla grave preoccupazione per il suo attuale sviluppo...»
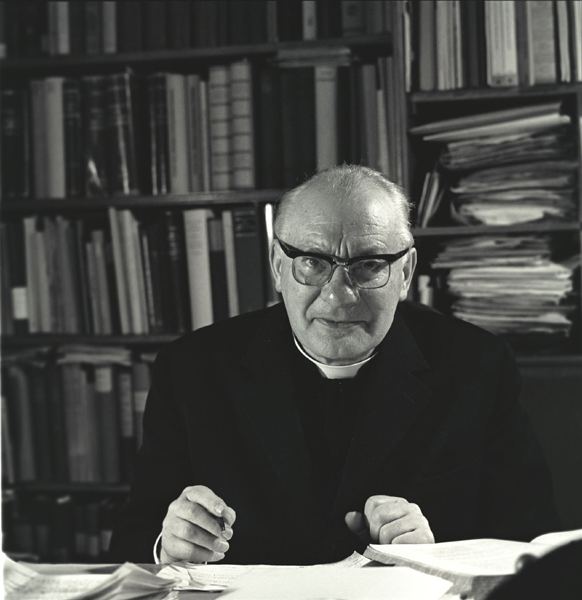
Bonn, 16 settembre 1968
Copia dattiloscritta. Nella lettera d’accompagnamento al cardinal Döpfner quale presidente della conferenza episcopale si legge: «Ci permettiamo di presentarLe in allegato alcune riflessioni e considerazioni sull’attuale situazione nella chiesa cattolica, pregandoLa di sottoporle ai membri della conferenza episcopale tedesca.
Le nostre riflessioni sono maturate dopo anni di attività scientifica sulla storia della chiesa e sono state dettate dalla grave preoccupazione per il suo attuale sviluppo. Siamo consapevoli che saranno in molti a trasmettere consigli più o meno competenti agli orecchi dei vescovi. Memori di quanto è stato detto in seno al Concilio Vaticano II circa la corresponsabilità dei sacerdoti e dei laici, ci sentiamo tuttavia nel dovere morale di esporre le nostre esperienze e conoscenze, affinché il reverendissimo episcopato non manchi di categorie di valutazione, poiché quello che per il singolo è l’esperienza di vita, per la comunità ecclesiale è la storia della chiesa».
Promemoria
La chiesa cattolica sta attraversando attualmente una grave crisi. Anche la Germania, per lo meno la Repubblica Federale, ne è coinvolta. Nel Katholikentag, celebrato a Essen, tale crisi si è resa ampiamente manifesta, e in questo contesto l’enciclica Humanae vitae non va considerata la causa, bensì l’occasione, il momento scatenante.
Tale crisi suggerisce a noi, storici particolarmente esperti della storia della Riforma, alcuni paralleli con gli avvenimenti che nel XVI secolo hanno portato alla divisione della chiesa occidentale. Questo ci induce a trarre dall’esperienza della storia conclusioni utili alla valutazione del presente della chiesa.
I
Le ricerche compiute negli ultimi decenni hanno dimostrato che Martin Lutero non intendeva dividere la chiesa, quando nell’anno 1517 presentò le sue tesi sull’indulgenza ai vescovi competenti, per poi pubblicarle. Gradualmente egli si separò dall’autorità della chiesa, a Lipsia (1519) rifiutò anche il carattere vincolante delle decisioni prese nei concili ecumenici regolari, e la vasta risonanza, che nemmeno lui aveva previsto, lo indusse alla fine a non accettare la condanna - ritardata peraltro troppo a lungo - delle sue 41 tesi nella bolla Exsurge Domine (1520). Nelle diocesi tedesche questa decisione del papa venne in parte taciuta, in parte resa pubblica in maniera inadeguata. I vescovi considerarono il «caso Lutero» come una contesa fra teologi, senza accorgersi che con ciò venivano non solo scossi, ma distrutti i fondamenti del concetto di chiesa cattolica. Ad eccezione di pochi teologi, i credenti videro in Lutero colui che riscopriva la vera dottrina della salvezza, rinnovando la chiesa; lo considerarono il liberatore dal giogo che, a loro avviso, era stato loro imposto dalla chiesa fino a quel momento.
Gli antesignani più accesi ed attivi del movimento luterano furono gli «intellettuali» di allora, gli umanisti, ai cui occhi la teologia sviluppatasi fino a quei tempi, la scolastica, costituiva un ostacolo al progresso; inoltre molti sacerdoti e religiosi che, affascinati dal motto della «libertà evangelica», si liberarono dei vincoli assunti; infine alcuni ceti minacciati dal pericolo del declino sociale, come i cavalieri dell’impero e, in gran parte della Germania, i contadini benestanti. Il successo quasi pieno del movimento luterano negli anni fra il 1517 e il 1525 fu reso possibile dal dominio dell’unico mezzo di comunicazione allora esistente, di cui la chiesa non riconobbe a sufficienza l’importanza: la stampa. Gli scritti di Lutero e i numerosi opuscoli che riportavano le sue idee erano richiestissimi ai «commessi viaggiatori di libri». Essi erano scritti nel linguaggio parlato dal popolo e venivano letti, quasi divorati con estremo interesse. I pochi ammonitori, teologi in grado di vedere le cose in modo più chiaro, ma d’altra parte mediocri propagandisti, non vennero letti e furono considerati «reazionari». I titolari del magistero ecclesiastico, papa e vescovi, tacevano; il concilio, continuamente richiesto e atteso con ansia, non veniva indetto. Perdurava un senso di incertezza nella fede.
Senza voler minimamente attenuare gli errori e le omissioni compiuti allora anche e proprio dalla curia romana, si deve dire che la passività dell’episcopato tedesco - che dal punto di vista teologico aveva una formazione assolutamente insufficiente e nel cui stile di vita e nella cui coscienza (salvo poche eccezioni) il principe aveva il primato sul vescovo - ha facilitato l’affermazione pressoché indisturbata del movimento luterano, vorrei dire che lo ha fondamentalmente reso possibile. Così i vescovi tedeschi persero l’occasione propria per intervenire; poiché dopo che la maggioranza delle città imperiali e dei principi ebbero fatta propria la causa di Lutero (dopo il 1526), fu troppo tardi per qualsiasi intervento. Senza il coinvolgimento dei vescovi vennero fondate e ampliate chiese regionali luterane e giurisdizioni ecclesiastiche cittadine. Il movimento luterano si organizzò e si consolidò, si diede una confessione, strinse un patto politico-militare; nella chiesa lo scisma divenne realtà. Oggi sappiamo che il processo interno di divisione, la formazione della «confessione», non è durata anni, bensì decenni.
Melantone e Calvino si dichiararono cattolici fino alla fine dei loro giorni; i sostenitori della vecchia fede vennero diffamati come «papisti». Il popolo dei fedeli continuò a rimanere legato alla messa e ai suoi santi, e gli ordinamenti ecclesiastici introdotti dai magistrati luterani assunsero molte caratteristiche proprie del cattolicesimo, persino processioni e pellegrinaggi. La massa dei semplici fedeli non si rese dunque consapevole del fatto che la «riforma» non era una riforma della chiesa, bensì la formazione di una chiesa nuova, impostata su base diversa. Considerando la cosa a posteriori, bisogna dunque constatare che nulla ha favorito lo scisma religioso tanto quanto l’illusione della sua non esistenza. Tale illusione era diffusa a Roma e in seno all’episcopato tedesco, in molti teologi, nella maggioranza del clero in servizio pastorale e nel popolo.
A questo punto sono d’obbligo alcune analogie fra la situazione di allora e quella odierna. Vi è tuttavia una differenza sostanziale: lo scisma del XVI secolo divenne verso il 1530 sempre più una questione delle «autorità», dunque dello stato. Lo stato di oggi è indifferente di fronte agli avvenimenti della chiesa. Là dove non è indifferente e, come nei paesi comunisti, pone sotto forte pressione la chiesa, i fenomeni di crisi esposti qui di seguito mancano o sono presenti in forma molto attenuata. Solo nel mondo libero dell’Occidente essi hanno potuto svilupparsi, approfittando nel contempo della ribellione contro il cosiddetto «establishment».
II
Come nel XVI secolo, l’attuale crisi della chiesa in Germania è, nella sua essenza più profonda, insicurezza e disorientamento nella fede. La critica protestante della Bibbia è penetrata con un ampio fronte nella teologia cattolica. Ciò non riguarda tanto i titolari delle cattedre di esegesi, i quali sono per lo più prudenti nelle loro formulazioni, quanto piuttosto i loro studenti e uditori, spesso teologicamente e filologicamente impreparati; questi assumono acriticamente concetti di teologi protestanti radicali, per esempio di Bultmann, e li diffondono semplicisticamente e grossolanamente nelle scuole superiori, a congressi e in occasione di corsi, così come nella predicazione. Sotto lo schermo della ermeneutica viene messo in dubbio il carattere vincolante di definizioni dogmatiche dei concili ecumenici (per esempio quello della transustanziazione); viene allentato, se non del tutto rifiutato, il legame fra la teologia e il magistero della chiesa, e il magistero stesso viene screditato, addirittura messo in ridicolo. A favorire questa dissoluzione del concetto cattolico di chiesa è l’avversione all’autorità, propria della nostra epoca, diffusa nella generazione più giovane e sostenuta da molti genitori e pedagoghi; inoltre il disprezzo di qualsiasi forma di obbedienza, anche e soprattutto dell’obbedienza religiosa.
A chiedersi: «Che cosa c’è ancora di cattolico?» sono non solo i cattolici di una certa età o i cosiddetti «cattolici tradizionalisti», ma anche la schiera scelta dei credenti onesti e autentici. Tale interrogativo non è neppure indotto dalle continue trasformazioni delle forme liturgiche e dall’arbitrio sempre più dilagante nelle funzioni religiose, esprime bensì autentica insicurezza e conflitto di coscienza. I mezzi di comunicazione moderni sono oggi infinitamente più potenti di quelli del XVI secolo. Sono manovrati quasi senza eccezione da intellettuali che spesso, anche se e proprio perché sono cattolici, promuovono e diffondono il «nuovo», facendolo passare per «progressista» a proprio uso e consumo, senza tener conto del contenuto di verità; nello stile e nel modo di esprimersi essi ricorrono sempre a slogan tipici della giovane generazione («democratizzazione della chiesa»), sul teleschermo minimizzano o mascherano le loro azioni di disturbo e commentano in senso ben determinato fatti religiosi in generale. Essi creano - per meglio dire manipolano - l’«opinione pubblica», di fronte alla quale solo pochi, fra i molti milioni di spettatori televisivi, sono in grado di farsi un’opinione personale. La continua «irrigazione» subita dai credenti attraverso i mezzi di comunicazione in mano alla «sinistra» ecclesiale deve trasformare il loro rapporto con la chiesa, e in realtà lo ha già fatto. Il senso di disorientamento avanza di mese in mese. Quanto più a lungo durerà, tanto maggiore diventerà, come nel XVI secolo, il pericolo di uno scisma religioso, oppure - cosa che sarebbe ancora peggiore - di un completo processo di estraniamento dalla chiesa, così come singole gocce d’acqua si disperdono nell’arida sabbia.
Noi non crediamo che l’istituzione e il sostegno di gruppi e movimenti conservatori e tradizionalisti («Una voce», «Nunc et semper» e altri) sia la via giusta per impedire la minaccia dello scisma o della decadenza della chiesa. Affidare ad una «destra» ecclesiale la lotta contro le aberrazioni della «sinistra» sarebbe una fondamentale abdicazione da parte delle autorità che la chiesa cattolica, a differenza delle comunità protestanti, possiede, grazie alla sua struttura basata sul diritto divino. Queste autorità devono parlare in maniera chiara ed agire con decisione, vale a dire senza riguardo alla propria popolarità. Se faranno questo, e lo faranno entro breve tempo, si vedrà che esse hanno dietro di sé la grande massa del popolo dei fedeli ancora cattolici. Se nei primi anni dello scisma del XVI secolo i vescovi tedeschi si fossero subito uniti per un’azione comune, prima che la Riforma divenisse un fatto politico, la divisione della chiesa avrebbe forse potuto essere ridotta ad una semplice sfaldatura, se non proprio essere evitata completamente. L’episcopato attuale non è più gravato ed ostacolato da carente formazione teologica, né dalla sua posizione sociale o dai coinvolgimenti politici che ne derivano. La costituzione Lumen gentium gli ha conferito ampi diritti e possibilità, ma anche una maggiore responsabilità nei confronti dell’integrità della fede. I vescovi non possono più permettersi di attendere l’intervento delle supreme autorità religiose, ma devono intervenire di persona. Là dove i mezzi di comunicazione pubblici erigono mura di silenzio o consentono di osservare gli avvenimenti reali solo attraverso lenti distorte, è doppiamente indispensabile la loro parola chiarificatrice e il loro comportamento coerente. Ad ogni cattolico e non cattolico deve essere chiaro che i vescovi considerano come loro primo e supremo dovere la tutela e la custodia integrale del patrimonio di fede.
III
Alcuni esempi concreti possono forse spiegare come ci immaginiamo tale «comportamento».
1. Professori universitari e insegnanti di religione, i quali insegnino palesemente eresie, devono venire privati della missio canonica; si deve prevedere che da ciò deriveranno conflitti con le autorità statali e con i gruppi di pressione «di sinistra».
Parroci e cappellani che si oppongano apertamente alla disciplina ecclesiastica nell’insegnamento o con il loro comportamento (per esempio nei confronti della santa Eucaristia) devono venire sospesi, anche se da ciò possono derivare temporaneamente gravi carenze nella cura d’anime.
Non si deve aver paura di creare dei «martiri»; bisogna dare un esempio ammonitore - preoccupandosi tuttavia di facilitare agli interessati il passaggio ad una professione laica, mediante un’adeguata assistenza.
2. Nessun candidato al sacerdozio può venire consacrato, qualora non assuma esplicitamente e incondizionatamente su di sé i doveri del sacerdozio, accettando l’obbedienza canonica. Soprattutto sono da escludere dalla consacrazione gli autori di dichiarazioni contro il celibato, contro scritti del magistero del papa e dei vescovi, nonché gli istigatori di rivolte e ricatti in convitti e seminari.
È molto meglio avere un numero di gran lunga inferiore di sacerdoti e provvedere alla meno peggio a una gestione provvisoria delle comunità vacanti, consacrando diaconi uomini sposati e già di una certa età, piuttosto che fuorviare intere comunità con sacerdoti ribelli o demagogici.
3. Deve essere rivolta molta più attenzione alla formazione dei «teologi laici», ai quali la missio canonica va conferita con maggiore scrupolosità. Una parte di loro ispira la «sinistra» ecclesiale e promuove - consapevolmente o meno - l’insicurezza e la mancanza di chiarezza nella fede.
4. A tutto il clero va fatto capire che la liturgia non è libera «creazione» di una riunione comunitaria, bensì servizio divino regolato dalla chiesa. Ci si prende ormai tale arbitrio nella liturgia, che le formule di consacrazione vengono liberamente cambiate da singoli chierici. La messa in latino, elemento di unione della chiesa universale, non può tramontare in questa nostra epoca, che mira a creare «un mondo uno». In ogni chiesa con più messe domenicali, una dovrebbe rimanere di regola in latino. Sarà ben frequentata, come stanno a dimostrare esperienze fatte.
5. Nella formula magisteriale, espressioni come «democratizzazione della chiesa» oppure «cattolicesimo critico» e simili devono venire respinte, a causa degli errori che traspaiono da esse riguardo all’essenza della chiesa, e deve venire raccomandata la dottrina della chiesa sulla base della costituzione Lumen gentium. I princìpi tradizionali di «sussidiarietà» e «solidarietà» sono certo sufficienti per assicurare la collaborazione dei laici alla realizzazione del mandato apostolico. Non si deve avere timore di lasciare nel vocabolario della chiesa i concetti di «autorità» e di «obbedienza».
6. Il movimento che mira non ad un «aggiornamento» giustamente inteso, bensì, come nel XVI secolo, a una rivoluzione della chiesa, è presumibilmente, almeno al momento, meno organizzato di quanto si potrebbe supporre o temere. Si deve tuttavia tenere in conto l’impressione motivata che questo movimento rivoluzionario disponga di centri d’organizzazione nell’ambito del cattolicesimo. In questo contesto andrebbe verificata senza grettezza, ma anche senza farsi illusioni, la funzione delle comunità studentesche cattoliche, per un eventuale intervento immediato: è meglio sciogliere le comunità studentesche e ritornare alla delega a singoli sacerdoti assistenti spirituali, come quattro decenni fa, piuttosto che promuovere la disgregazione della dimensione ecclesiale.
La medesima cosa vale per la Lega della gioventù cattolica e per la scelta dei sacerdoti della diocesi e del decanato, destinati ad assistere gli studenti.
7. Infine non è da trascurare che le emittenti radiofoniche e televisive - compresa la radio della chiesa - sono orientate «a sinistra», salvo poche eccezioni. Non sarà possibile rompere dall’oggi al domani la loro dittatura; vale comunque la pena cercare di incidere con autorità ponderata e lungimirante; non accontentarsi soprattutto di singole decisioni di politica in rapporto alle persone, bensì mantenere costanti contatti con i pubblicisti e i giornalisti, attraverso competenti incaricati della chiesa.
8. Non si può soddisfare la richiesta di «democratizzazione» dei giornali ecclesiali, avanzata ad Essen in occasione del Katholikentag, poiché in questo modo cadrebbero gli ultimi rimasugli di una stampa non dominata dalla «sinistra» ecclesiale e andrebbe perduta l’unica possibilità, che hanno ancora le autorità religiose, di informare i credenti al di fuori dell’ambito ecclesiale.
IV
Nei paralleli qui tracciati e nelle proposte riportate a titolo d’esempio abbiamo tenuto certo conto del fatto che nel movimento ecclesiale attuale sono presenti anche forti impulsi religiosi - così come nel XVI secolo per il movimento promosso da Lutero. Per entrambe le situazioni valgono le parole di sant’Agostino: «Nulla porro falsa doctrina est, quae non aliqua vera intermisceat» (Quaest. ev. II 40). Siamo tuttavia convinti che ciò che di buono e di vero è venuto alla luce nel nuovo risveglio della chiesa durante il concilio e attraverso il concilio, può fruttificare solo se viene separato dall’errore.
Quanto più verrà rinviata la dolorosa azione di taglio, tanto maggiore diverrà il pericolo che forze preziose vadano perdute perché coinvolte nell’errore, e che assistiamo non solo alla scissione nella chiesa, bensì anche all’apostasia dal cristianesimo.
Quanto più i vescovi parleranno in termini chiari e agiranno con decisione, tanto maggiore sarà la possibilità di mantenere il movimento di risveglio all’interno della chiesa e in tal modo conservare la chiesa stessa.
16 settembre 1968
