G.S. e la grande comunità della Chiesa
- Curatore:
G.S. è uno strumento di passaggio, un tratto provvisorio di quella strada che ognuno deve percorrere per andare verso il regno di Dio.
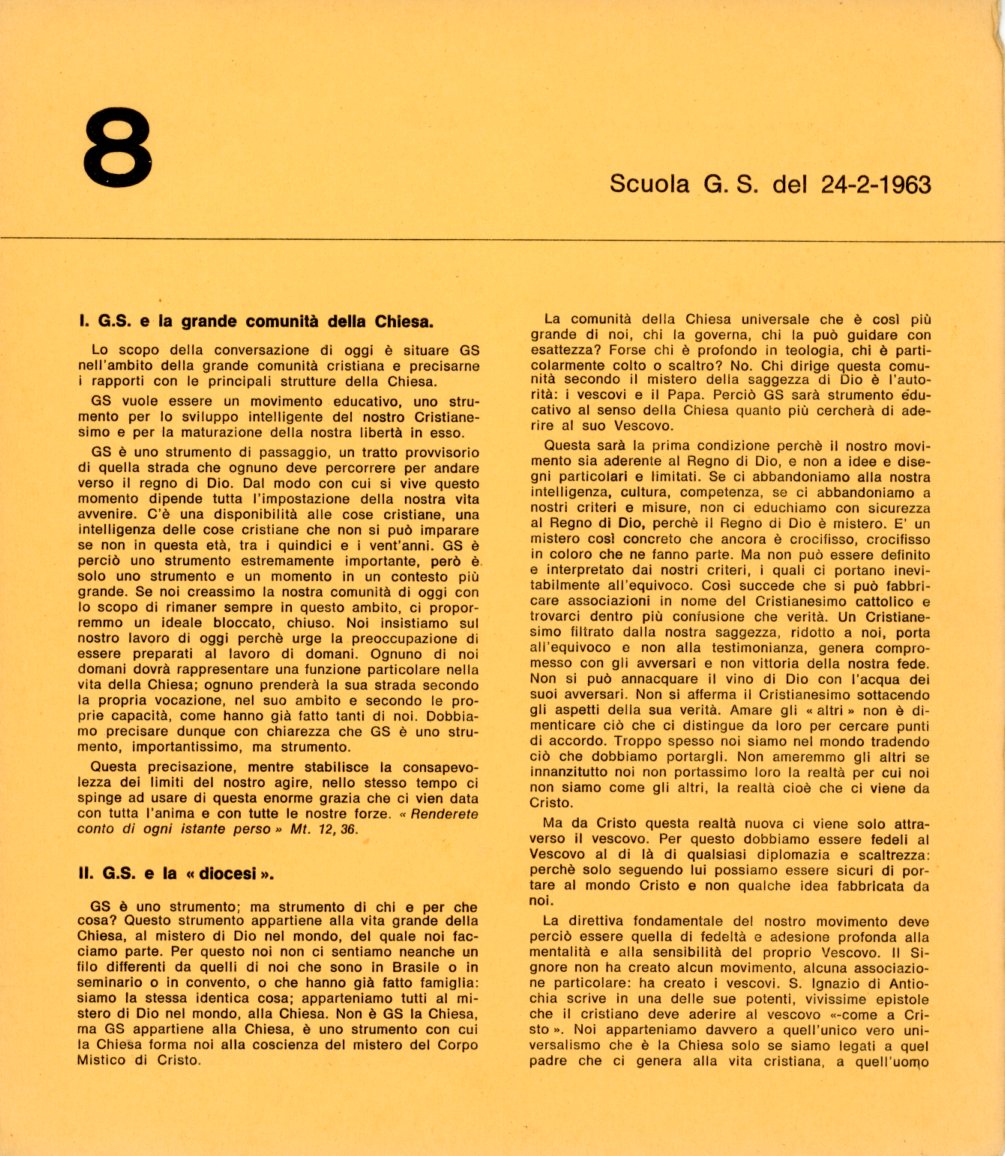
8
1. G.S. e la grande comunità della Chiesa.
Lo scopo della conversazione di oggi è situare G.S. nell’ambito della grande comunità cristiana e precisarne i rapporti con le principali strutture della Chiesa.
G.S. vuole essere un movimento educativo, uno strumento per lo sviluppo intelligente del nostro Cristianesimo e per la maturazione della nostra libertà in esso.
G.S. è uno strumento di passaggio, un tratto provvisorio di quella strada che ognuno deve percorrere per andare verso il regno di Dio. Dal modo con cui si vive questo momento dipende tutta l’impostazione della nostra vita avvenire. C’è una disponibilità alle cose cristiane, una intelligenza delle cose cristiane che non si può imparare se non in questa età, tra i quindici e i vent’anni. G.S. è perciò uno strumento estremamente importante, però è solo uno strumento e un momento in un contesto più grande. Se noi creassimo la nostra comunità di oggi con lo scopo di rimaner sempre in questo ambito, ci proporremmo un ideale bloccato, chiuso. Noi insistiamo sul nostro lavoro di oggi perché urge la preoccupazione di essere preparati al lavoro di domani. Ognuno di noi domani dovrà rappresentare una funzione particolare nella vita della Chiesa; ognuno prenderà la sua strada secondo la propria vocazione, nel suo ambito e secondo le proprie capacità, come hanno già fatto tanti di noi. Dobbiamo precisare dunque con chiarezza che G.S. è uno strumento, importantissimo, ma strumento.
Questa precisazione, mentre stabilisce la consapevolezza dei limiti del nostro agire, nello stesso tempo ci spinge ad usare di questa enorme grazia che ci vien data con tutta l’anima e con tutte le nostre forze. «Renderete conto di ogni istante perso» Mt. 12, 36.
2. G.S. e la «diocesi».
G.S. è uno strumento; ma strumento di chi e per che cosa? Questo strumento appartiene alla vita grande della Chiesa, al mistero di Dio nel mondo, del quale noi facciamo parte. Per questo noi non ci sentiamo neanche un filo differenti da quelli di noi che sono in Brasile o in seminario o in convento, o che hanno già fatto famiglia: siamo la stessa identica cosa; apparteniamo tutti al mistero di Dio nel mondo, alla Chiesa. Non è G.S. la Chiesa, ma G.S. appartiene alla Chiesa, è uno strumento con cui la Chiesa forma noi alla coscienza del mistero del Corpo Mistico di Cristo.
La comunità della Chiesa universale che è così più grande di noi, chi la governa, chi la può guidare con esattezza? Forse chi è profondo in teologia, chi è particolarmente colto o scaltro? No. Chi dirige questa comunità secondo il mistero della saggezza di Dio è l’autorità; i vescovi e il Papa. Perciò G.S. sarà strumento educativo al senso della Chiesa quanto più cercherà di aderire al suo Vescovo.
Questa sarà la prima condizione perché il nostro movimento sia aderente al Regno di Dio, e non a idee e disegni particolari e limitati. Se ci abbandoniamo alla nostra intelligenza, cultura, competenza, se ci abbandoniamo a nostri criteri e misure, non ci educhiamo con sicurezza al Regno di Dio, perché il Regno di Dio è mistero. E’ un mistero così concreto che ancora è crocifisso, crocifisso in coloro che ne fanno parte. Ma non può essere definito e interpretato dai nostri criteri, i quali ci portano inevitabilmente all’equivoco. Così succede che si può fabbricare associazioni in nome del Cristianesimo cattolico e trovarci dentro più confusione che verità. Un Cristianesimo filtrato dalla nostra saggezza, ridotto a noi, porta all’equivoco e non alla testimonianza, genera compromesso con gli avversari e non vittoria della nostra fede. Non si può annacquare il vino di Dio con l’acqua dei suoi avversari. Non si afferma il Cristianesimo sottacendo gli aspetti della sua verità. Amare gli «altri» non è dimenticare ciò che ci distingue da loro per cercare punti di accordo. Troppo spesso noi siamo nel mondo tradendo ciò che dobbiamo portargli. Non ameremmo gli altri se innanzitutto noi non portassimo loro la realtà per cui noi non siamo come gli altri, la realtà cioè che ci viene da Cristo.
Ma da Cristo questa realtà nuova ci viene solo attraverso il vescovo. Per questo dobbiamo essere fedeli al Vescovo al di là di qualsiasi diplomazia e scaltrezza: perché solo seguendo lui possiamo essere sicuri di portare al mondo Cristo e non qualche idea fabbricata da noi.
La direttiva fondamentale del nostro movimento deve perciò essere quella di fedeltà e adesione profonda alla mentalità e alla sensibilità del proprio Vescovo. Il Signore non ha creato alcun movimento, alcuna associazione particolare: ha creato i vescovi. S. Ignazio di Antiochia scrive in una delle sue potenti, vivissime epistole che il cristiano deve aderire al vescovo «come a Cristo». Noi apparteniamo davvero a quell’unico vero universalismo che è la Chiesa solo se siamo legati a quel padre che ci genera alla vita cristiana, a quell’uomo attraverso il quale unicamente passa la vita che ci rigenera: il vescovo.
Si chiama «diocesi» quel brano autentico di Chiesa universale che è proprio del vescovo. Perciò la prima direttiva del nostro movimento deve essere l’integrazione profonda alla vita della Diocesi.
3. G.S. e la «parrocchia».
I vescovi animano la vita della loro diocesi affidandone singole zone a dei collaboratori, i sacerdoti: nasce così la parrocchia (dal greco parà oichìa = vicino alla casa).
Dal momento che i vescovi insistono su questa struttura, dobbiamo portarle profonda fedeltà e indirizzare verso di essa i risultati ultimi del nostro lavoro comune.
Ma perché la Chiesa pone in ogni luogo il vescovo e i suoi parroci? Perché per educare al Cristianesimo occorre che la voce cristiana raggiunga l’uomo nel suo ambiente. E la parrocchia è appunto l’ambiente delle case, normalmente fondamentali per la vita dell’uomo.
Ma, ai fini della formazione di un individuo, «ambiente» è quel luogo di rapporti che di fatto più influisce e determina l’evoluzione dell’individuo stesso, specialmente come mentalità e sensibilità. Ora, c’è un periodo nella vita del giovane in cui gli fa più impressione quel che vede attorno che quel che gli dicevano da piccolo a casa. L’ambiente della casa rimane sempre il fattore originale, ma è un altro l’ambiente che più lo influenza ormai: è l’ambiente della scuola e del lavoro, la televisione, il cinema – ciò che c’è di più collettivo. La nostra società usa questi strumenti in un modo terribilmente invadente, per cui a una certa età il legame alla propria casa e alla parrocchia viene battuto in breccia da una concorrenza molto più forte. Allora la Chiesa è costretta a desiderare che i giovani siano raggiunti dalla potenza del suo aiuto proprio là dove il mondo coi suoi mezzi collettivi penetra più facilmente nel cervello e nel cuore. Occorre perciò che anche negli ambienti frequentati dal ragazzo tra i quindici e i vent’anni, la scuola e il lavoro, la comunità della Chiesa trovi presenza ed espansione.
Normalmente, la parrocchia non dispone di un metodo sufficiente per contrastare l’influsso delle componenti sociali non cristiane dell’ambiente della scuola e del lavoro: è questo invece il compito e il valore dei movimenti studenteschi e di lavoratori.
Il più grosso problema alla nostra età è quello di sentire veramente un richiamo alla Chiesa e di educarci in esso. Ma un’azione che vuol essere educativa deve tener conto della situazione dell’individuo da educare: deve cioè investirlo là dove più è impressionato, dove maggiormente subisce influssi, negli ambienti che frequenta. E per questo occorre una agilità di spirito che sappia anche mutare per un po’ metodi e forme pur così utili in tempi diversi. «Non è l’uomo per la legge, ma è la legge per l’uomo». Come i genitori sanno che non possono pretendere dal ragazzo di diciassette anni ciò che esigevano da lui quando ne aveva sette, e lo lasciano perciò più libero, perché possa rimanere tra loro e lui un contatto vero, analogamente anche la parrocchia, cui al fondo siamo sempre legati, deve saper all’occasione diventare più larga nei suoi rapporti con noi.
Il movimento che viviamo non è perciò affatto in contrasto con quella struttura originale che è la parrocchia. Anzi vuol essere lo strumento per salvare i germi cristiani da essa trasmessi nei ragazzi, vuol essere il tentativo di recuperare i giovani che essa non riesce più a impegnare in una riscoperta viva del Cristianesimo.
Quanto più cresceremo ora nella fedeltà al mistero di Dio nel mondo, tanto più, fatti maturi, riprenderemo il nostro posto nelle strutture antiche.
Noi ripetiamo ben chiaro a noi stessi e a tutti che nostra preoccupazione è quella di integrarci profondamente in tutte le forme della vita cattolica della nostra terra.
Ciò che crea e giustifica la nostra solidarietà e la nostra comunità particolare di ora è la possibilità e la realtà di un richiamo e di un aiuto più aderente ed efficace per una educazione a chiarezza, ad intensità, a fedeltà e a sacrificio cristiano per noi giovani. G.S. è solo questo.
