«Solo un Dio potrà salvarci»
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
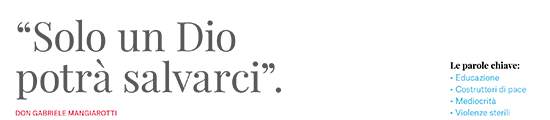
Certo che, se leggiamo le notizie di questi giorni, non c’è da stare molto allegri. E dico leggere, perché proprio non mi va di guardare la televisione. Basta proprio scegliere a caso tra le notizie e ci troviamo di fronte alla terribile notte di Capodanno a Colonia, con le tante donne maltrattate e umiliate da un considerevole numero di immigrati. Basta leggere di quei ragazzini minacciati dopo che venne loro posta la domanda «Credete in Dio o in Allah?»
Sembra davvero che la liturgia cristiana di questi giorni trovi conferma nei tanti fatti accaduti: «il popolo che camminava nelle tenebre… La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli…», tanto da farci chiedere se «solo un dio potrà salvarci» come affermava, poco prima di morire, il filosofo Horkheimer.
Ma proprio i testi indicati ci hanno detto che la speranza è la parola definitiva di quel Dio in cui crediamo. E tale speranza potrà ricucire i rapporti tra gli uomini.
Credo che la speranza, tra noi, debba rivestire i panni della educazione, debba suggerire, in particolare ai giovani, che una vita vera è possibile, che il futuro, che dipende da Dio, ha bisogno delle nostre mani, che la «preghiera semplice» di san Francesco (Signore, dov’è odio ch’io porti il perdono…) indica una prospettiva di bene e bellezza e convenienza senza paragone, a condizione che la nostra libertà si muova in quella direzione.
Allora ritrova la sua evidenza quanto il santo Papa Giovanni Paolo II suggeriva nel suo primo messaggio per la pace: «Per vincere questo spontaneo sentimento d'impotenza, il primo compito e vantaggio di un'educazione degna di questo nome è di rivolgere lo sguardo al di là delle tristi realtà immediate o, piuttosto, d'imparare a riconoscere, all'interno stesso delle esplosioni di violenza omicida, il cammino discreto della pace, che giammai si arrende, che instancabilmente guarisce le ferite, che conserva e fa progredire la vita. Allora, il cammino verso la pace apparirà possibile e desiderabile, deciso e già vittorioso. Impariamo, anzitutto, a rileggere la storia dei popoli e dell'umanità secondo schemi più veri di quelli di una semplice concatenazione di guerre e di rivoluzioni. Certo il rumore delle battaglie domina la storia; ma sono le pause della violenza che hanno permesso di attuare quelle durature opere culturali, che fanno onore all'umanità. Anzi, se si son potuti trovare, nelle guerre e nelle rivoluzioni stesse, dei fattori di vita e di progresso, questi derivavano da aspirazioni di un ordine ben diverso da quello della violenza: aspirazioni di natura spirituale quali la volontà di veder riconosciuta una dignità comune a tutta l'umanità, di salvaguardare l'anima e la libertà di un popolo. Laddove tali aspirazioni erano presenti, esse operavano come elemento regolatore in seno ai conflitti, impedivano fratture irrimediabili, conservavano una speranza, preparavano una nuova favorevole occasione per la pace… L'educazione alla pace può allora beneficiare anche di un rinnovato interesse per gli esempi quotidiani dei semplici operatori di pace a tutti i livelli: sono quegli individui e quelle famiglie che, mediante il dominio delle proprie passioni, l'accettazione e il rispetto vicendevoli, raggiungono la pace interiore e la irradiano; sono quei popoli, spesso poveri e provati, la cui saggezza millenaria s'è plasmata attorno al bene supremo della pace, popoli che hanno saputo resistere spesso alle ingannevoli seduzioni di progressi rapidi raggiunti con la violenza, convinti che simili guadagni avrebbero portato con sé i germi avvelenati di nuovi conflitti. Sì, pur non ignorando il dramma delle violenze, apriamo gli occhi nostri e quelli delle giovani generazioni a queste visioni di pace: esse eserciteranno un'attrattiva decisiva. Soprattutto, esse libereranno l'aspirazione alla pace, che è costitutiva dell'uomo. Queste energie nuove faranno inventare un nuovo linguaggio di pace e nuovi gesti di pace… Giovani, siate dei costruttori di pace! Voi siete operatori a pieno titolo in questa grande opera comune. Resistete alle comodità che addormentano nella triste mediocrità e alle violenze sterili con cui talvolta certi adulti, che non sono in pace con se stessi, vogliono strumentalizzarvi. Seguite le strade sulle quali vi spinge il vostro senso della gratuità, della gioia di vivere, della compartecipazione».
E vorrei concludere con una considerazione finale, che diventa domanda a cui rispondere in prossimi interventi. In questo Anno della Misericordia, come potremo vivere le opere della misericordia Corporale e Spirituale? Quale attualità e possibilità hanno l’invito a «visitare i carcerati» o «consigliare i dubbiosi»? perché quanto accade ci invita ad essere operatori di bene e strumenti di pace. Sempre, e dovunque.

