Il «richiamo» non è «propaganda»
- Curatore:
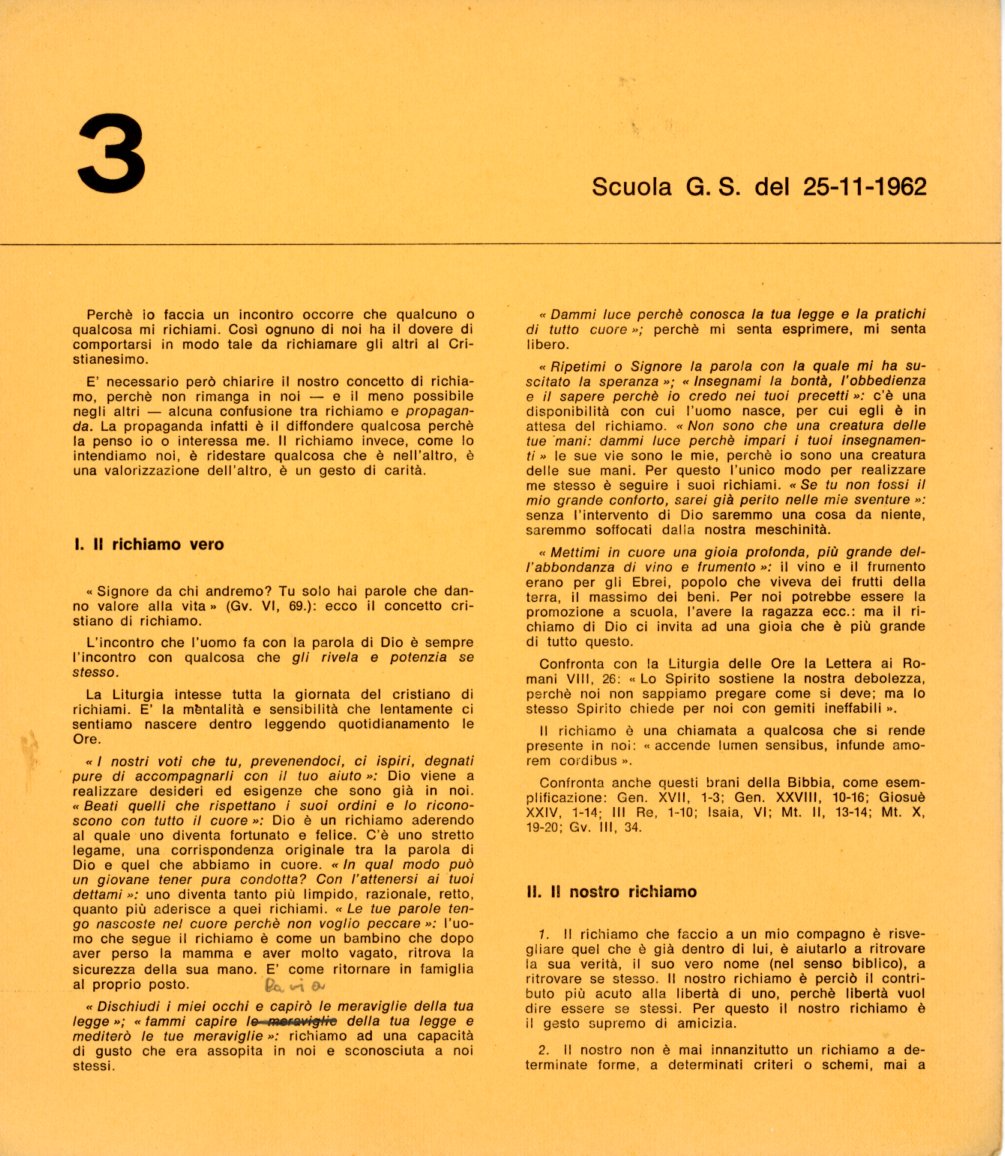
Perché io faccia un incontro occorre che qualcuno o qualcosa mi richiami. Così ognuno di noi ha il dovere di comportarsi in modo tale da richiamare gli altri al Cristianesimo.
E’ necessario però chiarire il nostro concetto di richiamo, perché non rimanga in noi – e il meno possibile negli altri – alcuna confusione tra richiamo e propaganda. La propaganda infatti è il diffondere qualcosa perché la penso io o interessa me. Il richiamo invece, come lo intendiamo noi, è ridestare qualcosa che è nell’altro, è una valorizzazione dell’altro, è un gesto di carità.
1. Il richiamo vero
«Signore da chi andremo? Tu solo hai parole che danno valore alla vita» (Gv. VI, 69.): ecco il concetto cristiano di richiamo.
L’incontro che l’uomo fa con la parola di Dio è sempre l’incontro con qualcosa che gli rivela e potenzia se stesso.
La Liturgia intesse tutta la giornata del cristiano di richiami. E’ la mentalità e sensibilità che lentamente ci sentiamo nascere dentro leggendo quotidianamente le Ore.
«I nostri voti che tu, prevenendoci, ci ispiri, degnati pure di accompagnarli con il tuo aiuto»: Dio viene a realizzare desideri ed esigenze che sono già in noi. «Beati quelli che rispettano i suoi ordini e lo riconoscono con tutto il cuore»: Dio è un richiamo aderendo al quale uno diventa fortunato e felice. C’è uno stretto legame, una corrispondenza originale tra la parola di Dio e quel che abbiamo in cuore. «In qual modo può un giovane tener pura condotta? Con l’attenersi ai tuoi dettami»: uno diventa tanto più limpido, razionale, retto, quanto più aderisce a quei richiami. «Le tue parole tengo nascoste nel cuore perché non voglio peccare»: l’uomo che segue il richiamo è come un bambino che dopo aver perso la mamma e aver molto vagato, ritrova la sicurezza della sua mano. E’ come ritornare in famiglia al proprio posto.
«Dischiudi i miei occhi e capirò le meraviglie della tua legge»; «fammi capire le meraviglie della tua legge e mediterò le tue meraviglie»: richiamo ad una capacità di gusto che era assopita in noi e sconosciuta a noi stessi.
«Dammi luce perché conosca la tua legge e la pratichi di tutto cuore» perché mi senta esprimere, mi senta libero.
«Ripetimi o Signore la parola con la quale mi ha suscitato la speranza»; «insegnami la bontà, l’obbedienza e il sapere perché io credo nei tuoi precetti»: c’è una disponibilità con cui l’uomo nasce, per cui egli è in attesa del richiamo. «Non sono che una creatura delle tue mani: dammi luce perché impari i tuoi insegnamenti» le sue vie sono le mie, perché io sono una creatura delle sue mani. Per questo l’unico modo per realizzare me stesso è seguire i suoi richiami. «Se tu non fossi il mio grande conforto, sarei già perito nelle mie sventure» senza l’intervento di Dio saremmo una cosa da niente, saremmo soffocati dalla nostra meschinità.
«Mettimi in cuore una gioia profonda, più grande dell’abbondanza di vino e frumento»: il vino e il frumento erano per gli Ebrei, popolo che viveva dei frutti della terra, il massimo dei beni. Per noi potrebbe essere la promozione a scuola, l’avere la ragazza ecc.: ma il richiamo di Dio ci invita ad una gioia che è più grande di tutto questo.
Confronta con la Liturgia delle Ore la Lettera ai Romani VIII, 26: «Lo Spirito sostiene la nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si deve: ma lo stesso Spirito chiede per noi con gemiti ineffabili».
Il richiamo è una chiamata a qualcosa che si rende presente in noi: «accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus».
Confronta anche questi brani della Bibbia, come esemplificazione: Gen. XVII, 1-3; Gen. XXVIII, 10-16; Giosuè XXIV, 1-14; III Re. 1-10; Isaia. VI; Mt. II, 13-14; Mt. X, 19-20; Gv. III, 34.
2. Il nostro richiamo
1. Il richiamo che faccio a un mio compagno è risvegliare quel che è già dentro di lui, è aiutarlo a ritrovare la sua verità, il suo vero nome (nel senso biblico), a ritrovare se stesso. Il nostro richiamo è perciò il contributo più acuto alla libertà di uno, perché libertà vuol dire essere se stessi. Per questo il nostro richiamo è il gesto supremo di amicizia.
2. Il nostro non è mai innanzitutto un richiamo a determinate forme, a determinati criteri o schemi, mai a una organizzazione particolare; ma a quella promessa che costituisce il cuore stesso dell’uomo, la realtà umana stessa di coloro che richiamiamo. Noi riecheggiamo quello che Dio ha loro messo in cuore creandoli, mettendoli in un dato ambiente, formandoli. Proprio per questo non sappiamo dove Dio li condurrà, prendendo magari spunto dalla nostra parola: il disegno è Suo. Non possiamo sapere quella che sarà la loro vocazione.
Il nostro è perciò innanzi tutto un richiamo a ciò che costituisce il valore della vita di un uomo, a un destino, a una vocazione, al compimento di questa, e basta.
3. Difetti e modalità del nostro richiamo
1. G.S. è solo ciò con cui chiamo, il punto di partenza.
Noi non crediamo facilmente che il Regno di Dio è un mistero: dobbiamo educarci a questo, dobbiamo tenere questo spazio alla libertà del mistero per non essere indiscreti o impazienti. Se noi richiamiamo i nostri compagni alla realtà cristiana pretendendo, consciamente o no. che arrivino a determinate conclusioni o a determinati risultati, allora non miriamo al mistero del Regno di Dio, ma ai nostri disegnini. Ciò ci impedisce di essere limpidi e generosi nel cercare e nell’attendere a ogni briciola di positivo che vi è negli altri.
2. Il nostro richiamo può essere attivismo preconcetto e superficiale.
Attivismo preconcetto: perché consegue meccanicamente una posizione che abbiamo abbracciata quasi fosse il nostro partito. A volte pretendiamo che qualcuno arrivi a capire le cose seguendo un cammino fissato da noi, mentre invece infinite sono le vie del Signore.
Attivismo superficiale: in quanto non cerca di adeguarsi con acutezza e con pazienza (con carità) alla situazione dell’altro. Per questo ci capita di affrettarci a mettere a uno una determinata etichetta, affidandogli il tale incarico senza aspettare «il momento giusto», senza aspettare una maturazione della sua sensibilità o semplicità.
3. Ciò a cui la realtà cristiana ci chiama è molto più un cammino che un traguardo.
Non bisogna considerare la persona staticamente, ma occorre innanzitutto che noi siamo esseri in cammino. Non possiamo basare il nostro sforzo sull’angoscia di una perfezione ottenuta con le sole nostre forze. E questo dobbiamo tener presente anche per gli altri, altrimenti al fondo troveremo una delusione: o per noi stessi, perché ci si ritrova sempre coi nostri difetti; o per gli altri perché la gente non cambia come vorremmo, o per l’umiliazione sottile di vedere quelli che noi abbiamo chiamato diventare più bravi di noi.
4. Occorre rivivere il richiamo; occorre richiamare l’altro rivivendo i motivi per cui lo richiamiamo.
E’ proprio lo splendore, l’espressione di questo nostro rivivere che costituisce il richiamo all’altro.
Perciò il richiamo non è qualcosa di estrinseco a noi, quasi un compito fuori di noi. Quando uno ha perso la vivezza dell’adesione, richiama a freddo, come esponendo una formula o una ideologia; la sua è spesso una propaganda che genera solo discussioni: lui stesso si sente estraneo all’altro.
D’altra parte anche se uno ha sbagliato, si sente inaridito, e così via, il dover richiamare gli altri costituisce spesso il modo con cui Dio scuote lui stesso dalla cattiva posizione o dalla stanchezza!
5. Dobbiamo richiamare non a delle formule o a una ideologia, ma a dei fatti, a un impegno di vita.
E’ solo questo che «prepara la strada del Signore», come richiamava S. Giovanni Battista.
Dobbiamo far sì che tutto il nostro modo di fare, le iniziative che assumiamo, gli inviti che diamo, siano pervasi e vivificati da una preoccupazione ideale. Noi abbiamo tutte le preoccupazioni degli altri, perché sono umane. Ma in noi c’è qualcosa di più: in noi ogni gesto è sotteso dalla preoccupazione profonda di amare l’uomo, di aiutarlo cioè ad essere veramente libero, a camminare verso il suo destino. Questa è la legge della carità: il desiderio che l’altro sia se stesso, che si «salvi».
Noi vogliamo essere gente che va a scuola con la preoccupazione di prendere il bel voto ed evitare quello cattivo, con la curiosità di sapere avvenimenti e cose, con il desiderio di vivere rapporti che riempiano il tempo e impediscano la noia: ma vogliamo soprattutto essere gente che sotto tutto questo sempre si reca a scuola, entra nel gruppo degli amici con una preoccupazione ideale.
Se questa preoccupazione diventa normale in noi, l’occasione del richiamo ci verrà da ogni cosa, ogni cosa potrà ispirarci.
Ma perché ogni cosa ci ispiri, occorre dapprima essere fedeli ai richiami cui non possiamo sottrarci: quelli della comunità e dell’autorità.
