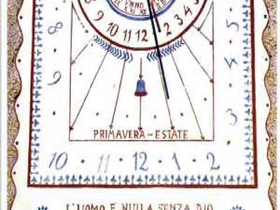Gesù Nazareno, il Santo di Dio - 1: Pietro e Andrea
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:

La "rivelazione" degli spiriti immondi
Lasciata la scena rocciosa del deserto con angeli e fiere, l'obiettivo attento di Marco si fissa su Simone, colui che un giorno prenderà il nome di Pietro, diventando una roccia per la comunità dei discepoli. Il primo arco narrativo del Vangelo di Marco si apre, infatti, con la descrizione di una giornata di Gesù, vista soprattutto attraverso gli occhi di Simone.
È Simone con suo fratello Andrea il primo ad essere chiamato al seguito di Gesù. In casa di Simone avviene anche il primo miracolo di Gesù, in cui già si adombra il mistero della risurrezione, la guarigione della suocera di Pietro arsa dalla febbre. Ancora, la misteriosa e intensa preghiera notturna di Gesù rivolta al Padre, viene interrotta da una richiesta di Simone che parla, già fin da questo momento, a nome degli altri, tanto dei discepoli che delle folle.
Cuore di questa giornata è, tuttavia, l'incontro con uno spirito immondo che "rivela" anzitempo l'identità del Cristo: Gesù Nazareno, il Santo di Dio. La lotta contro satana nel deserto con la quale Marco chiudeva l'introduzione al suo vangelo si perpetua nella vita quotidiana e missionaria di Gesù.
Per alcuni il termine Nazareno deriva da Nazaret ed evoca perciò la provenienza di Gesù. Alla luce di questa interpretazione possiamo capire alcune espressioni evangeliche: «da Nazaret potrà mai venire qualcosa di buono?» (Gv 1, 46). Oppure ancora: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice forse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?» (Gv 7,41-42). Altri però vogliono far derivare l'appellativo da «nazireo», termine con cui venivano chiamati i votati al nazireato, una sorta di consacrazione a Dio - normalmente temporanea - che prevedeva una vita ascetica, manifestata nel segno esteriore del non bere vino e del non tagliare i capelli.
In ogni caso il nome Gesù Nazareno rimanda alla condizione umana di Gesù: Cristo non è un semi dio, ma è Uomo, vero Uomo. Egli è il Dio entrato nella storia per la porta comune di una madre,a porta comune di una madre, che è il Dio che possiede una patria e, dunque, ha una provenienza. Requisiti del tutto diversi da quelli del Messia che gli Israeliti si aspettavano e che si pensavano simili, almeno per certi aspetti, a quelli di Melchisedec, re e sacerdote di Salem a cui Abramo pagò la decima di tutto. Di questo personaggio, misteriosa prefigura del Messia, si dice che non aveva né patria né genealogia. Il Cristo invece, possiede l'una e l'altra cosa.
I demoni lo chiamano anche il Santo di Dio, una delle formule più antiche che la prima cristianità usava per affermare la divinità di Gesù. Con il termine il Santo, infatti, si indicava anzitutto il sancta sanctorum, il Luogo della Presenza, il luogo della scekinà e, in definitiva, Dio stesso. L'espressione è dunque forte e richiama l'identità profonda del Gesù di Nazaret, vero uomo ma, nel contempo, vero Dio.
Alcuni studiosi definiscono gli spiriti immondi «i teologi di Marco», essi infatti, con due soli appellativi sintetizzano l'intero mistero del Verbo Incarnato. Quanto asserito dai demoni, gli uomini non lo comprendono, perciò la loro singolare "professione di fede" viene puntualmente certificata da eventi, che gli uomini possono intendere e vagliare.
Gesù, dopo il ritiro nel deserto, appare sulla scena comportandosi come ogni rabbi degno di rispetto: acquistandosi discepoli. Rimane una differenza sostanziale però con i rabbi dell'epoca, una differenza che sconcerta le folle. Solitamente, infatti, i rabbi non si sceglievano mai i discepoli, erano piuttosto i discepoli che, dopo aver ascoltato la predicazione dei vari maestri, sceglievano quello che meglio rispondeva alle loro esigenze. Non così Gesù che si sceglie e chiama i suoi discepoli, spesso in circostanze particolari, come quella del normale lavoro quotidiano: la pesca.
Gesù si manifesta subito, in Marco, come colui che scruta i cuori che possiede la signoria sull'uomo e sulla sua coscienza.
La Vocazione di Pietro e Andrea del Ghirlandaio
Il 27 ottobre 1481 Papa Sisto IV chiamò a Roma, Cosimo Rosselli e Piero di Cosimo suo allievo, Botticelli, il Perugino e il Pinturicchio, il Signorelli e il Ghirlandaio per dipingere nella Cappella Sistina due cicli di affreschi che narrassero storie di Cristo e di Mosè. Alcuni di questi affreschi andranno perduti per far posto al capolavoro di Michelangelo. Del Ghirlandaio, che dipinse anche una Risurrezione (perduta), ci rimane l'affresco che illustra la Vocazione i Pietro e Andrea (Figura 1).
Il Ghirlandaio, seguendo la lezione di Marco, fissa l'obiettivo su Simone e il fratello per narrare qualcosa della prima giornata pubblica di Gesù.
Fin dal primo sguardo ci si accorge di essere di fronte ad episodi in sequenza, poiché la persona di Gesù viene ripetuta tre volte. Le tre scene, che vanno lette da destra a sinistra, rimandano al passaggio del sole sulla meridiana verticale.
Pochi anni prima dell'esecuzione di questo affresco, nel 1475, Paolo dal Pozzo Toscanelli installò nella lanterna della Cupola di santa Maria del Fiore in Firenze uno gnomone, asta bronzea la cui ombra, proiettata sul pavimento dell'interno della basilica, permette di misurare la posizione del Sole in cielo [1]. Lo gnomone (Figura 2), alto 90 metri di altezza il più grande nel suo genere, serviva ad individuare il momento esatto del solstizio e quindi la durata dell'anno. L'evento - fece grande scalpore e non passò certo inosservato al Ghirlandaio che nel 1476 si trovava a Firenze con il fratello Davide.
La prima giornata di Gesù è raffigurata perciò dal Ghirlandaio con il passaggio della luce e allo zenit, a mezzogiorno, egli pone al centro di un folto gruppo di uomini il Cristo, ricolmo della maestà di Dio, che conferisce a Pietro e ad Andrea un nuovo mandato: diventare pescatori di uomini.
Alle sue spalle due scene di chiamata. La prima a sinistra quella di Simone e Andrea, l'altra a destra quella di Giacomo e Giovanni.
La vocazione di Simone e Andrea rimane sullo sfondo, quasi nascosta dal gruppo centrale, la scena lascia però intravvedere lo sconcerto dei due pescatori di fronte alla solennità della chiamata di questo rabbi stravagante. Sulla riva opposta, Pietro e Andrea, ormai assoldati al seguito di Gesù e perciò stesso santi, sono testimoni della chiamata di altri due discepoli: Giacomo e Giovanni. La quasi perfetta simmetria delle due scene dice la simultaneità delle due chiamate e la prontezza delle risposte e rende bene quell'immediatezza che Marco stesso sottolinea: Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono (Mc 1,16-20).
Il mandato missionario - seguitemi vi farò pescatori di uomini - conferito anzitutto a Pietro (Figura 3) e poi, nella presenza di Andrea, a tutti gli altri apostoli, riprende un'immagine dei profeti minori che, particolarmente in Abacuc, possiede un'accezione negativa: Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone. Egli li prende tutti all'amo, li tira su con il giacchio, li raccoglie nella rete, e contento ne gode (Ab1,14-15). Gesù re-interpreta il passo lasciando intendere ai suoi discepoli che avrebbero sottratto gli uomini dal caos del male (di cui il mare era segno) per condurli alla salvezza.
In corrispondenza di quest'affresco del Ghirlandaio, facente parte del ciclo sulla Storia di Gesù, si trova quello del passaggio del Mar Rosso di Cosimo Rosselli, appartenente invece, al ciclo sulla Storia di Mosè. In tal modo il raduno dell'antico popolo dell'Alleanza, delineato sullo sfondo del Mar Rosso, viene messo in parallelo alla convocazione del nuovo popolo, colta dal Ghirlandaio presso il cosiddetto mar di Galilea.
La Galilea apre e chiude il Vangelo di Marco: tanto la proclamazione del regno da parte di Gesù che le apparizioni del Risorto sono ambientate in Galilea. L'evangelista Matteo, citando un passo di Isaia (Is 8,23- 9,1) definisce questa terra Galilea delle genti per la presenza di molti goìm (pagani), essa viene così a rappresentare il punto principale di contatto tra Israele e le nazioni pagane. Fin dal primo apparire di Gesù sulla scena, si delinea l'apertura che la chiesa avrà nei confronti dei pagani: un messaggio importante per i cristiani di Roma a cui il Vangelo era destinato [2].
Vediamo infatti (Figura 4), che dietro a Pietro e ad Andrea, inginocchiati in primo piano, si trova una folla di uomini e giovani tutti intenti a fissare lo sguardo su Gesù autore e perfezionatore della fede. In questa folla, il Ghirlandaio ritrae diverse personalità del suo tempo: Giovanni Tornabuoni (in prima fila e terzo da destra) zio di Lorenzo il Magnifico e tesoriere del Papa, Cecco Tornabuoni, Giovanni Antonio Vespucci, il greco umanista Giovanni Agiropulo (in primo piano con la barba bianca) e tanti altri. Si tratta per lo più di fiorentini influenti che avevano residenza anche a Roma. Sisto IV, chiedendo al Ghirlandaio di rappresentarli in una affresco così fondante per la funzione di Pietro nella Chiesa, intendeva così esplicitare la sottomissione delle autorità fiorentine a quella di Roma e del papato.
Il Ghirlandaio, come l'evangelista Marco, mettendo al centro l'apostolo Pietro (segno del magistero Petrino), mentre dispiega il rivelarsi del mistero di Cristo, rivela nel contempo (indissolubilmente congiunto) il mistero della Chiesa. Lo preannunciano gli uccelli nel cielo che planando verso le acque del mare suggeriscono l'idea della presenza del pesce, abbondante e pronto per essere pescato. Inoltre, rompendo con le loro silouettes lo spazio luminoso del cielo obbligano l'osservatore a scrutare l'orizzonte e a scorgere dentro il profilo scuro delle colline, anacronistici campanili, testimoni di una terra ormai evangelizzata.
Dietro Gesù vediamo dispiegarsi, invece, un'altra folla non più in abiti quattrocenteschi, ma vestita alla maniera palestinese. Questa folla non è attenta e composta come quella di destra, ma è animata: alcune persone parlottano, altre, incuranti della scena principale, voltano le spalle a Gesù, altre ancora lo guardano con aria interrogativa.
Il dipinto offre uno spaccato delle reazioni della folla registrate anche dall'evangelista Marco. Sullo sfondo del lago di Galilea, Marco, infatti, osserva, fin dall'inizio della predicazione di Gesù, due atteggiamenti diversi da parte della gente. Da un lato la folla, che si meraviglia per l'autorità con cui Gesù parla e, dunque, lo segue con desiderio, lo cerca, porta a lui malati da guarire. Dall'altro scribi e farisei che restano perplessi e si scandalizzano per la libertà con cui Gesù opera anche di sabato.
Note
[1] Allo gnomone fu applicata la bronzina, cioè il foro gnomonico, poiché il Sole, infatti, è una sorgente estesa, l'ombra del vertice dello gnomone non è nitida, ma sfuma in una penombra mal definita. Il modo più efficace di aumentare il contrasto è di sostituire l'ombra con la luce e cioè di usare il foro gnomonico al posto del palo, come è stato fatto in S. Maria del Fiore. Si ottiene così sul pavimento un'immagine abbastanza nitida del Sole, molto più luminosa della superficie circostante. [2] Secondo alcuni studiosi Marco avrebbe scritto il suo Vangelo dopo il 70 quando cioè, i romani divennero molto ostili ai giudei a causa della grande rivolta dell'anno 70. Ponendo l'annuncio del vangelo in Galilea lo si distaccava il più possibile da Gerusalemme e dal giudaismo in generale.