"Perelandra" 4 - Un'opera complessa
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
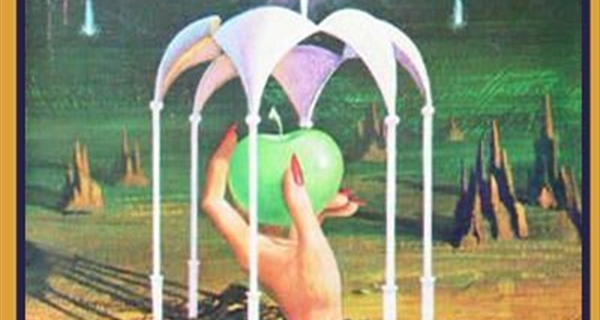
Un’opera complessa
Fantateologia? Mito basato su archetipi junghiani? Avventura drammatica? Polemica antiscientista? Esemplificazione del Senso del Meraviglioso (sense of wonder)? In parte forse anche tutto questo, ma molto di più. “Perelandra” è un romanzo di grande complessità, con diversi livelli di lettura e una ricchezza di tematiche veramente straordinaria. Non a caso la miriade di contributi critici che lo ha esplorato ha formulato tutta la serie di interpretazioni sopra accennate. La percezione di trovarsi di fronte ad un’opera fuori dal comune è avvertibile anche nel breve compendio di storia della letteratura fantascientifica tratteggiato nell’Introduzione a “Destinazione Universo” (siamo nel 1957!):
“Il livello qualitativo medio (della letteratura di FS, n.d.r.) si era notevolmente elevato, innanzitutto per l’esempio di opere come “Il Mondo Nuovo” di A. Huxley, “Perelandra” di C. S. Lewis, “Cronache marziane” di Ray Bradbury, “1984” di G. Orwell, la “Conquista dello spazio” di A. Clarke…” (5)
La diffusione a livello di massa di “Perelandra” non poté usufruire in Italia del poderoso traino costituito per “Lontano dal pianeta silenzioso” dalle tavole a fumetti del 1957 de “La Domenica del Corriere”; ma la prestigiosa “Medusa” mondadoriana lo annoverò tra i propri capolavori già nel 1951. La genesi del secondo romanzo della trilogia è documentata con una certa ampiezza da Lewis stesso, dapprima in un articolo: “Tutto cominciò con una scena”:
“Di una cosa sono convinto. Tutti i miei sette libri su Narnia e i tre di fantascienza sono cominciati vedendo delle scene nella mia testa”. (6)
E poi in una conversazione alla buona con Brian Aldiss e Kingsley Amis:
“LEWIS - Il punto di partenza del secondo romanzo, Perelandra, fu una mia rappresentazione mentale di isole galleggianti. Tutto il resto del mio lavoro consisteva, in un certo senso, nel costruire un mondo in cui potessero esistere isole galleggianti. E poi naturalmente si sviluppò la storia di una caduta evitata. Questo perché, come sapete, avendo portato la gente in questo eccitante paese, qualcosa deve pure accadere.
AMIS - Il che di solito mette la gente a dura prova.
ALDISS - Mi sorprende che la mettiate in questi termini. Avevo creduto di capire che Perelandra era stato ideato con un intento didattico.
LEWIS - Sì, lo pensano tutti, e sbagliano.
AMIS - Se posso dire una parola da parte del professor Lewis, c'era sicuramente un intento didattico; una quantità di cose profonde, interessantissime, sono state dette ma - correggetemi se sbaglio - ho pensato che solo un senso di meraviglia, mentre avvenivano cose tanto straordinarie, fosse il vero motivo che ispirava la creazione.
LEWIS - Verissimo, ma qualcosa doveva pure accadere. La storia di quella caduta evitata ci stava benissimo. Naturalmente non ci sarebbe stata quella storia lì se, per altro verso, non mi avessero interessato quelle particolari idee. Ma il punto di partenza non è quello. Io non sono mai partito da un messaggio o da una morale: e voi?
AMIS - No, mai. Si è sempre presi dall'interesse per una situazione.
LEWIS - La storia stessa vi impone una sua morale, che si scopre mentre si scrive il racconto”. (7)
Il vero interesse di Lewis
Quali siano le “particolari idee” che interessavano Lewis è mirabilmente spiegato da Pietro Schenone in questa sintesi:
“La storia della vita e dell'opera di C.S. Lewis è segnata da una duplice esperienza: quella di un desiderio, così profondo da non poter trovare una
risposta, che sta nell'anima come il Siège Perilous nel castello di re Artù (sul quale nessuno che non fosse il Predestinato poteva sedersi), e quella della risposta ad esso, impossibile all'uomo eppure certa, perché la natura non fa niente a caso. Più di ogni altro scrittore moderno, Lewis ha avvertito l'universalità di questa esperienza e, forse per questo, l'ha posta al centro di tutti i suoi libri.” (8) La nostalgia della gioia è il tema ricorrente dell’opera di Lewis, fin dal suo primo romanzo: “Le due vie del pellegrino”, storia di un ritorno a casa alla ricerca del significato della vita e della felicità. (9)
In questa dinamica, che raffigura il nocciolo dell’umana condizione, si inserisce anche una lotta drammatica, perché vi è un nemico che ostacola il cammino dell’uomo verso il proprio significato. Così rilegge il “nucleo infiammato” del pensiero di Lewis il critico Edoardo Rialti:
“Tutta l’opera di Lewis si muove entro questi due elementi: la menzogna che il diavolo accampa nel cuore dell’uomo, facendogli credere di poter ottenere da solo la sua felicità, e la presenza, dolcissima e terribile, del vero Amore di ogni uomo, che incalza e preme perché l’uomo a sua volta Lo riconosca e Lo ami, e in questo trovi finalmente se stesso”. (10)
NOTE
5. AA. VV., Destinazione Universo - Racconti di fantascienza a cura di Piero Pieroni - illustrazioni di Leo Mattioli - Vallecchi Editore Firenze 1957, pag. XIII.
6. C. S. LEWIS, Tutto cominciò con una scena, in Radio Times, Junior Radio Times, vol. CXLVIII (15 luglio 1960), cit. in “Altri mondi”, Ed. Paoline, 1969, pag. 78.
7. “Luoghi irreali”, conversazione tra C. S. Lewis, K. Amis e B. Aldiss (“Unreal estates”, in Encounter, volume XXIV, marzo 1965), in “Altri mondi”, Ed. Paoline, 1969, pp. 142-143.
8. PIETRO SCHENONE, Lewis, inserto di “Litterae communionis” n. 5, marzo 1982, pag. II.
9. CLIVE STAPLES LEWIS, Le due vie del pellegrino (The Pilgrim’s Regress: an allegorical apology for Christianity, Reason and Romanticism, 1933), Jaca Book, Milano 1981.
10. E. RIALTI, Introduzione a C. S. LEWIS, Prima che faccia notte – Racconti e scritti inediti, a cura di E. Rialti, BUR, Milano 2005, pag. 14.
